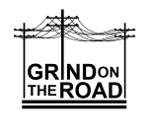È uscito il 29 agosto, a fine estate, e non poteva esserci momento più adatto. Thirst, il terzo album degli Slow Crush, è un disco che appartiene all’autunno e all’inverno, al freddo che taglia la pelle e ai tramonti che arrivano presto. Lo shoegaze del gruppo belga si colloca nella frangia più heavy del genere ed esprime al meglio quella combinazione irresistibile tra melodie eteree e sognanti, quasi provenienti da altri mondi, e muri di suono assolutamente travolgenti. A questo punto del loro percorso si percepisce chiaramente quanto abbiano affinato la loro formula: i paesaggi sonori di questo disco sono più densi che mai, respirano e si contraggono come onde furiose di un mare gelido che ti cattura dalla prima all’ultima traccia.
Proprio la prima in scaletta, la title-track “Thirst”, entra in scena come una botta improvvisa, un uragano che ti trascina dentro al disco senza chiedere permesso. È un pezzo adrenalinico che gioca anche con i tempi: dopo l’avvio accelera e rallenta in modo netto, tutto a beneficio della dinamicità. La batteria segue ogni scarto con una naturalezza impressionante, mentre le chitarre hanno quella ruvidità quasi grunge che gli Slow Crush sanno rendere onirica, grazie a un riverbero che le fa vibrare come metallo incandescente. La voce di Isa Holliday si muove tra rassegnazione e leggerezza eterea, e questa elasticità del brano le dà ancora più spazio. “Covet” raccoglie quel flusso e lo porta avanti con muri di chitarre che si dilatano e una batteria piena di piccoli movimenti e fill che tengono tutto in tensione. Sul finale si sente persino un sassofono, il che è una scelta piuttosto rara nello shoegaze. In questo caso però devo dire che ci sta benissimo, perché la coda finale si tinge di una velata malinconia che dà al pezzo quel non so che in più. Da qui Thirst comincia a mostrarsi per intero, perché “Cherry” è uno dei brani migliori del lotto. I riff iniziali hanno un’impronta alla Deftones, chitarre morbide nel timbro ma tese nel modo in cui si muovono, ed è un contrasto che secondo me funziona benissimo. La batteria intanto costruisce un crescendo che solleva il pezzo fino al suo apice, e nel ritornello finale la voce si apre con una dolcezza ipnotica che sta perfettamente in mezzo tra melodia e distorsione. Con “Leap” questa sensazione si amplifica: voce e chitarre avanzano come un’unica materia sonora, un flusso compatto in cui ritmo, rumore e melodia sembrano respirare insieme. L’impatto è enorme, e a quel punto non saprei nemmeno dire se arriva prima dalla batteria di Frederik Meeuwis, davvero una delle cose migliori del disco, o dal modo in cui la voce di Isa Holliday prende spazio e trascina tutto con sé con una carica emotiva rara. Nella sua interpretazione si sente un trasporto davvero sincero, che si traduce in brividi assicurati. “Hollow” apre un varco di sospensione ambient, con pad evocativi e voci di bambini che si dissolvono sullo sfondo, con suoni che richiamano quella vibe quasi fiabesca dell’immortale “Plainsong” dei The Cure. Isa canta “Drag me under / Breathe softer / Scream louder” e la sua voce scivola tra onde e riverberi fino al finale graffiante, dove urla lontane si intrecciano al mix e accendono il fuoco della catarsi più vera. Questi tre minuti di bellezza sono praticamente un grosso crescendo etereo che alla fine ti investe con tutta la sua intensità cinematica. In “Haven” l’energia malinconica delle chitarre fende l’aria: i riff puliti lasciano vibrare la nostalgia della voce, che emerge tra colpi di rullante fermi e decisi. È uno dei brani più spaziosi del disco, e la dolcezza dell’insieme, elevata dalla voce, si appoggia a un suono nervoso, freddo come i ghiacci del Baltico. Sotto la superficie però scorre un calore inquieto, e la batteria lo tiene vivo con rallentamenti mirati e improvvise accelerate che danno al brano un movimento continuo. “While You Dream Vividly” invece apre la parte più ampia e contemplativa dell’album con quel pianoforte malinconico iniziale; poi ovviamente ecco di nuovo l’imponente batteria e la dolcezza ultraterrena della voce, insieme alle chitarre che graffiano l’anima. Il brano spinge sul lato onirico, e unisce la solennità emozionale tipica del post-rock all’intimità di un sogno lucido. Se dovessi descriverla con un’immagine, direi che suona come se i My Bloody Valentine provassero a scrivere un pezzo post-rock immerso nelle atmosfere dei primi The Cure. Un brano davvero pazzesco. Nella travolgente “Bloodmoon” il leggero detune dei delay è a dir poco ipnotico: le chitarre fluttuano psichedeliche su un ritmo guidato magistralmente dalla batteria, sempre dinamica nei suoi cambi di velocità. Qui lo shoegaze dei Nostri lascia affiorare una malinconia che vibra insieme alla spinta dei muri di suono, e a tratti torna quella sensazione di straniamento sensoriale che i My Bloody Valentine hanno reso inconfondibile, filtrata però attraverso il linguaggio più cupo degli Slow Crush. La conclusione più ovattata accompagna l’ascolto verso “Ógilt”, altro pezzo ambient dopo “Hollow”: la nostalgia qua scorre potente, tra chitarre pulite delicatissime, piccoli accenni di synth, rumori bianchi ed effetti analogici che sembrano giungere da un’altra dimensione. “Hlýtt” chiude il disco e ne raccoglie tutta la tensione irreale. Dalle stesse atmosfere ovattate di “Ógilt” nasce quindi un brano potentissimo, sei minuti di pura essenza shoegaze in cui la voce si fa ancora più sfumata e psichedelica: “Drag me through the water / Cold lips on my face / In the end I’ll be here”. La traccia cresce senza sosta accumulando luce ed energia, e nel finale crolla su se stessa alternando immersioni profonde ad un’ultima, devastante risalita. L’effetto è quello di un risveglio brusco da un sogno vivissimo, quasi troppo reale per lasciarlo andare.
A fine ascolto Thirst lascia una sensazione limpida, quasi fisica, un po’ come tornare da una passeggiata invernale sentendo ancora il vento sulla pelle. Trovandosi un po’ scombussolati, ma anche stranamente appagati. È uno di quei dischi davvero indicati per quando si ha bisogno di un suono avvolgente dentro cui lasciar scorrere i pensieri; tutto il viaggio mantiene una forza costante, scorre compatto e invita a rientrarci subito. In questo terzo album gli Slow Crush sembrano davvero nel loro territorio: suonano sicuri, ispirati, e ogni brano aggiunge un tassello a un percorso che si apre sempre un po’ di più, sia musicalmente (è il loro disco più pesante) che emotivamente. Perché tra queste onde sonore così irruente si percepisce una fragilità molto vulnerabile, una tenerezza che rende tutto più umano. Per me questo è il loro lavoro migliore.
(Pure Noise Records, 2025)
1. Thirst
2. Covet
3. Cherry
4. Leap
5. Hollow
6. Haven
7. While You Dream Vividly
8. Bloodmoon
9. Ógilt
10. Hlýtt