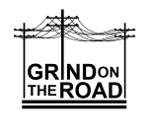VIDEO NASTY è un termine coniato in Inghilterra negli anni 80 dal comitato censura per indicare i film da VHS che avevano un contenuto violento o comunque mal visto.
Questa rubrica parla di cinema ed è a cura di Carmelo Garraffo ed Emiliano Zambon.
Se vuoi proporci un film da recensire o collaborare con noi, scrivi a redazione@grindontheroad.com
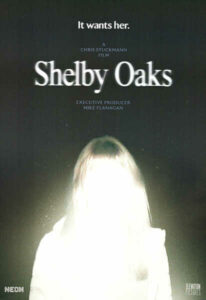 SHELBY OAKS di Chris Stuckmann (2024)
SHELBY OAKS di Chris Stuckmann (2024)
In sala in questi giorni il nuovo horror distribuito da NEON ha una storia produttiva un po’ particolare. Il suo regista, Chris Stuckmann, trentasettenne americano qui al suo debutto cinematografico, arriva da YouTube, esattamente come i colleghi australiani Philippou, registi di quei due film folgoranti come Talk to Me e Bring Her Back. Tutto inizia nel 2022 quando il nostro Chris decide di fare il salto e apre un Kickstarter per farsi finanziare un horror dai suoi follower. La risposta è incredibilmente positiva e Chris riesce a racimolare 650 mila dollari per girarlo. Il film si fa e comincia a venir mostrato nei festival già nel 2022. L’idea è semplice, fare un mokumentary mischiato alla fiction, quindi un finto documentario che a tratti diventa un film tradizionale. A seguire con interesse il progetto (prima) e a aiutare il regista nella post produzione (poi) c’è Mike Flanegan, proprio lui, quelle che si è fatto conoscere con le sue ottime serie horror su Netflix (e qualche film niente male di cui facciamo finta non esista Doctor Sleep). Ci mette qualche soldo, la sua competenza e il suo direttore delle musiche per sistemarlo dato che le prime proiezioni avevano mostrato un gradimento misto. Si perde un po’ di tempo a causa dello sciopero degli attori che avviene proprio in quel periodo e ci si mette un po’ a rimontare qualcosa e a ridoppiare alcuni passaggi. A lavoro finito il film viene comprato dalla NEON nel 2024 che decide di metterci altri soldi per girare alcune scene non presenti inizialmente a causa del budget. A questo punto si dice che il soldi spesi siamo ormai quasi il doppio e il film è finalmente pronto per l’uscita. A questo punto, tra una chiacchiera e una campagna marketing sottile e minimale i più attenti erano davvero molto curiosi di vedere il film, me compreso. Ora, ovviamente, vi starete chiedendo: “si ok, va bene, ma quindi il com’è?”. Datemi ancora un attimo. Shelby Oaks parla di una squadra di cacciatori del paranormale che fanno video su YouTube sui luoghi infestati che, a un certo punto, scompaiono nella cittadina che da il titolo al film, Shelby Oaks, e che, a un altro punto, vengono trovati morti. Tutti tranne una ragazza di nome Riley. Da qui inizia una ricerca da parte della sorella, vera protagonista del film. Senza dilungarmi molto vi dico subito che sulla carta Shelby Oaks ha una marea di problemi. Li ha nella scrittura e anche in tutta una serie di ingenuità infinite che cominciano da “ma la polizia che fa?” a “si ok a che serve andare in quel posto proprio di notte?”. Essendo una storia che parla di una sorella che, piano piano, scopre cose avvicinandosi sempre di più alla vera-verità uno si aspetterebbe una trama fatta di indizi e scoperte, che possano mandare avanti la narrazione piano piano ma non è proprio così. Le cose in questo film sembrano succedere e basta e la sensazione è che i personaggi girino a vuoto e che nulla sia davvero utile perché tanto, gli snodi e l’avanzamento del racconto, sarebbero successi comunque, anche se fossero rimasti fermi a fissare la parete di casa. Chiedersi continuamente a cosa è servita fare o non fare una cosa non è un qualcosa che lo spettatore dovrebbe chiedersi o, perlomeno, non qualcosa che vorrei chiedermi io guardando questo tipo di prodotto. Insomma, come dicevo, sulla carta Shelby Oaks è un mezzo disastro che mischia il mokumentary, found footage, le riprese tradizionali e (ta-dan) il folk horror che contiene satana per creare qualcosa di più o meno originale. Ma c’è un ma. Arrivati alla fine del film la sensazione è quella del dispiacere e non quella dell’aver perso del tempo con un brutto film perché, al suo interno, Shelby Oaks ha più di una cosa buona. L’atmosfera funziona e alcune scene fanno paura davvero mostrando diverse buone intuizioni che, forse complice la durata contenuta, riescono a tenerti li e a conquistarti abbastanza da farti tifare per il film. Finisce per farsi voler bene lasciando addosso le sensazioni giuste. È evidente che i problemi principali partano da lontano e da una storia che poteva essere scritta meglio di così. Il consiglio, se siete fan del genere, non è quindi quello di correre a vederlo appena potete ma se vi capita sotto gli occhi di dargli una possibilità con la mente e il cuore aperto a un piccolo film pieno di problemi ma che, tutto sommato, si fa ricordare. Qualcuno aiuto di Chris Stuckmann con la prossima sceneggiatura.
recensione di Carmelo Garraffo
N O OTHER CHOICE di Park Chan-work (2025)
O OTHER CHOICE di Park Chan-work (2025)
È arrivato per tutti gli appassionati di cinema il momento in cui ci si è scontrati con la cinematografia di Park Chan-wook e di solito il film con cui succede è OLDBOY. Per chi vi scrive è successo col film precedente, Mr Vendetta, ma solo perché in quegli anni ero già impazzito per il cinema asiatico (Coreano e Giapponese) riuscendo a intercettare un po’ prima quella bellissima ondata di registi e film incredibili che da li a poco ci avrebbe investito tutti quanti, spettatori e registi, cambiando le nostre vite e il cinema tutto per sempre (vedi alla voce “Tarantino”, che Oldboy negli Stati Uniti lo ha letteralmente spinto con il suo nome sopra i poster). Classe 1964 Park è un grande, cosa volete che vi dica. Senza di lui il cinema Coreano sarebbe un altra cosa e insieme a Bong Joon-Ho (Parasite) è una delle teste di serie del cinema che si fa da quelle parti. Spulciando la sua filmografia si va dal capolavoro a, quando va male, un film bellissimo, forse con l’eccezione Stoker, film comunque ben girato che aveva (per me) il problema di essere scritto da Wentworth Miller (si, quello di Prison Break) che, chiamalo scemo, chiamò il nostro Park a dirigere il suo primo film (salvandolo, visto che il secondo era brutto e poi le velleità sono finite li). Insomma, è il 2025 ed esce un nuovo film di Park Chan-wook e noi fan non possiamo fare altro che essere felici. Lo siamo anche perché il ritorno è in grande stile. Non che dovesse tornare effettivamente da qualcosa ma il suo precedente, il bellissimo Decision to Leave, era un noir elegante e dal ritmo più compassato rispetto ai soliti film del regista, che viravano anche su altro, e qui torniamo al mix di ordinario e straordinario, dramma e grottesco, con cui ci siamo innamorati del regista. La storia parte dal romanzo The Ax di Donald E. Westlake (1995) da cui un altro grandissimo regista, Costa-Gravas (a cui Park dedica questo film) ne avete giù tratto una versione, Cacciatore di teste (2005). Park ovviamente prende il racconto e ci fa una cosa sua. Il protagonista è un padre di famiglia che dopo 25 anni di onorato servizio nella sua azienda si ritrova licenziato e a dover quindi trovare un nuovo impiego finendo per eliminare uno a uno, letteralmente, tutti i probabili candidati alla posizione lavorativa disperatamente desiderata. Esattamente come fu per Parasite di Bong Joon-ho ci troviamo quindi davanti a un film che fa denuncia delle storture di una società Coreana (ma non solo) che costringe le persone a non avere altra scelta. Due ore e mezza che volano in un mix di dramma, risate e violenza che montano piano piano fine al finale. Se conoscete il regista sapete cosa aspettarvi, nel senso più positivo possibile. La sua regia è ispirata con quel montaggio e colonna sonora tipica delle sue opere migliori. Avete presente i film di quei registi che, mentre guardate, vi danno la sensazione di essere tornati a casa? Ecco. siamo esattamente in quei luoghi. Se non conoscete il regista siete pazzi e il consiglio è di andare a recuperare TUTTO QUANTO. Se invece lo conoscete il consiglio è il medesimo, ridotto a questo film. Guardatelo adesso, rimanere delusi non credo sia proprio possibile.
recensione di Carmelo Garraffo
 THE CONJURING: THE LAST RITES di Michael Chaves (2025)
THE CONJURING: THE LAST RITES di Michael Chaves (2025)
Il primo problema dell’ultimo film per il cinema (ne parliamo dopo) della saga di The Conjuring sta proprio qui sopra, nel nome del regista. Per chi avesse vissuto su Marte negli ultimi anni The Conjuring è una saga horror iniziata da James Wan (affidatagli dalla New Line Cinema), creatore di un altra lunga saga dal grande successo: SAW. L’idea è quella di portare a schermo, romanzando il più possibile. la vita dei veri coniugi Warren, sensitivi che negli anni sono divenuti famosi per tutta una serie di casi paranormali su cui sarebbero intervenuti in prima persona. Ovviamente nella vita vera credo siano stati dei grandi truffatori (basta un po’ guardarli in faccia) ma sullo schermo questa cosa funziona e la cosa, credo, la immaginassero pure loro dato che l’idea iniziale di portare al cinema le loro storie arriva proprio da loro che, per chi non lo sapesse, hanno girato per anni diverse case di produzione prima che qualcuno decidesse di dargli retta e fare un sacco di soldi. Il primo film è un piccolo manuale di come si gira un certo tipo di horror fatto di rumori, silenzi, porte che scricchiolano, tende che si muovono e tutto un corollario da meccanismi del vecchio cinema di genere. Wan è bravo e la coppia di protagonisti funziona molto sullo schermo garantendo così un successo duraturo, anche negli spin-off che ne allargano l’universo narrativo. James Wan imposta un universo che già da subito viene dato in mano a tutta una serie di piccoli registi che seguiranno comunque la sua impronta. Quello che mi sarei aspettato è un ritorno di Wan per il capitolo conclusivo ma invece così non è stato. Diciamoci la verità, tutti i registi che si sono susseguiti nei sequel e negli spin off non sono bravi quanto lui quindi, insomma, cavolo, ma perché dare un capitolo teoricamente tanto importante al regista che ha realizzato i peggiori film del franchiste? Non ha senso. Infatti questo “the last rites” non è davvero nulla di che o, perlomeno, non è nulla di che se pensiamo al fatto che è un capitolo conclusivo. Di base ci troviamo davanti al classico film del filone principale di The Conjuring, ovvero i coniugi Warren che non hanno nessuna voglia di intervenire ma che essendo puri di cuore alla fine accettano. Alcune scene funzionano e in generale non sarebbe così male ma il ritmo è davvero molto altalenante e ogni tanto guardandolo viene da chiedersi in che moda possa essere un capitolo conclusivo, fino a quando non si arriva al finale dove incolla una serie di sequenze in modo abbastanza frettoloso per introdurre il concetto di “Legacy”, ovvero dicendoci che il testimone passerà probabilmente dalle mani dei due coniugi a quella di altri due coniugi, la figlia e suo marito, chiudendo così la storia dei due protagonisti principali. Mi chiedo perché, se questa era l’intenzione, questo discorso non sia stato introdotto prima, film dopo film, invece di dare l’impressione di essere stato inserito e pensato solo adesso. Verrebbe anche da pensare che non sia vero che chiudono e che si voglia furbescamente fare una nuova saga ma con altri personaggi. Così non è però perché, poco prima dell’uscita di questo film, è stato più o meno confermato che c’è un progetto di una serie televisiva che andrà ad esplorare il passato, quindi un prequel, quindi una versione giovane dei sensitivi Warren. Ancora loro. Non siamo davanti a un film brutto, insomma, se siete fan della saga l’intrattenimento è assicurato e ritroverete tutto quello che cercate, un horror molto commerciale che ha la missione di intrattenere senza appesantire, in un modus operandi fatto di salti dalla sedia con i soliti meccanismi. Nulla di davvero nuovo sotto il sole, se lo chiedete a me, ma coerente con tutto quello fatto in precedenza. Rimane il rammarico di non essere davanti a un capitolo conclusivo che provi almeno un minimo ad alzare l’asticella o a chiudere col botto facendosi dimenticare molto in fretta e chiudendo in un modo non all’altezza una saga che, nel bene e nel male, ci ha accompagnato per parecchio tempo. Per completisti.
recensione di Carmelo Garraffo

PREDATOR: BADLANDS di Dan Trachtenberg (2025)
Che fine ha fatto il sottotesto? Per quanto riguarda il franchise di Predator sembra un po’ inutile parlarne a questo punto, dopo sei film e due tie-in con Alien. Ma la domanda che sorge proprio all’inizio di Badlands è molto semplice: cosa significa oggi questo personaggio? Quasi 40 anni fa, il grandioso capostipite ambientato nella giungla e ispirato alla guerra del Vietnam, metteva Arnold Schwarzenegger e una squadra di mercenari paramilitari contro un formidabile alieno cacciatore. Non importava chi o cosa fosse o da dove venisse: un incubo a occhi aperti, un mostro derivato dal subconscio dell’identità americana venuto a prendere a calci in culo lo zio Sam. Da questo punto di vista, Predator aveva molto in comune con lo xenomorfo di Alien, una creatura simile con intenti puri e spietati. Entrambi hanno collezionato sette film ciascuno e, dei due, solo lo xenomorfo ha -più o meno- mantenuto il suo mistero. Il predatore, invece, ha imboccato la via dei Na’vi di James Cameron: la sua gente sono gli Yautja, hanno i loro codici e costumi tradizionali, oltre a un linguaggio vero e proprio. Predator: Badlands ti sbatte tutto questo in faccia nei minimi dettagli e ti cala subito in una lotta tra due fratelli, l’abile figlio del capo e il fratello più giovane, l’anello più debole della famiglia, condannato a morte dal padre stesso per mano del primogenito. Dopo qualche contrasto, il giovane si imbatte in un’astronave che lo porta sul pianeta più pericoloso tra i mondi conosciuti con le parole del fratello che gli risuonano in testa: “Scegli la tua preda, portala a casa, guadagnati il posto tra noi o non tornare mai più”. Nel pianeta incontra Elle Fanning, un’androide a cui mancano entrambe le gambe, impertinente, ottimista e in grado di parlare fluentemente Yautja. I due fanno squadra, e mentre la ragazza rintraccia la parte inferiore del suo corpo, lo Yautja cerca il predatore alfa del pianeta. Assolutamente nulla di nuovo all’orizzonte, ma l’alchimia tra i due protagonisti è in qualche modo rinfrescante, e Schuster-Koloamatangi in particolare, nei panni dello Yautja, grazie al motion capture apporta una inaspettata profondità a quello che avrebbe potuto essere un semplice lavoro di make-up. Ciò che manca drasticamente, però, è un senso di minaccia reale in quello che è essenzialmente un buddy movie per famiglie con una marea di effetti speciali in CGI e senza un briciolo di violenza vera. Al suo posto c’è una sorta di psicoterapia familiare, la classica ossessione americana per la ricerca di legami significativi in una società competitiva: ciò che i due hanno in comune è che sono entrambi degli outsider, ostracizzati dai loro parenti più prossimi, il che conferisce al film il classico tiro da “trova la tua tribù”. Dan Trachtenberg è chiaramente nel suo ambiente qui, e il suo entusiasmo aiuta, in particolare nel ritmo, nell’estetica, e nell’impeccabile world building, ma le scene d’azione anche se abbastanza creative non galvanizzano mai, e da qualche parte lungo il percorso il predatore, un tempo una spietata e inarrestabile macchina per uccidere, ha semplicemente perso il suo minaccioso fascino. Tutto troppo soft e patinato, una sorta di versione Marvel, disneificata dell’universo ideato da John McTiernan nel 1986. L’ennesimo appiattimento PEGI-13 che rispetta i valori, il tono e l’estetica del prodotto Disney standard, di una saga che ha fatto della violenza e della brutalità il suo marchio di fabbrica, sostituita da squartamenti in CGI senza una goccia di sangue che non sia un arcobaleno di innocui fluidi dai mille colori (tranne il rosso ovviamente), e questo sicuramente non è di buon auspicio per l’inevitabile prossimo capitolo.
 FRANKENSTEIN di Guillermo del Toro (2025)
FRANKENSTEIN di Guillermo del Toro (2025)
Frankenstein di Guillermo del Toro è l’equivalente cinematografico di un bambino che si scatena in un negozio di giocattoli: non puoi negarne la gioia, ma nemmeno chiederti se avesse davvero bisogno di tutti quei balocchi. Questo è chiaramente il suo progetto del cuore, il suo parco giochi gotico, il suo santuario a Mary Shelley. E anche se la sua idea di estetica tra steam punk e gotico ipertrofico con me funziona, forse non si dovrebbe giocare sempre in modo così appassionato con i propri eroi quando si è troppo coinvolti emotivamente perché, certe volte, la devozione soffoca la creatività. Il film è pedissequamente fedele al libro, almeno all’inizio, citando Shelley testualmente come fosse uno studente troppo nervoso per parafrasare. Ma nella smania di raccogliere l’intero romanzo in due ore e mezza, al film, salvo qualche passaggio, non viene mai davvero concessa la possibilità di respirare. Oscar Isaac nei panni dello scienziato pazzo che parla con toni vittoriani come fosse una targa da museo ambulante è un cliché stravisto, scricchiolante e privo di originalità, al contrario del mostro tenero di Jacob Elordi che ha lavorato tanto per incarnare al meglio quella forza ingenua e primordiale che caratterizza il personaggio originale, mentre esteticamente si presenta come una via di mezzo tra una statua da gypsoteca e un macchinario anatomico della cappella di San Severo, forse la cosa migliore del film a livello estetico. Peccato del Toro non gli renda un gran servizio scegliendo di eliminare uno dei momenti più vitali del romanzo: l’omicidio di una bambina da parte della creatura. Non a favore del ritmo, non a favore delle tempistiche, ma apparentemente per riluttanza a macchiare di un delitto così atroce il suo amato mostro. Sebbene il trucco abbia funzionato con tutti i suoi lavori precedenti, la dedizione a simpatizzare con il diverso è, francamente, ridondante in Frankenstein. Senza quell’atto di brutalità, la creatura perde le sue contraddizioni, la sua tragica dualità. Diventa un semplicistico simulacro del dolore, privato degli strati che Shelley ha scolpito in lui. Quindi quello che ci resta è sostanzialmente un’opera imbottita e decomposta. Un film bello da vedere e con occasionali momenti riusciti, ma così preso dall’estetica di temporali e macchinari steampunk da, ironicamente, scordarsi proprio la scintilla vitale.
recensione di Emiliano Zambon
TOXIC AVENGER di Macon Blair (2023)
Ecco, io non ho dubbi che Macon Blair sia un vero fan di Toxic Avenger, come l’abbondanza di easter egg e inside jokes tromiani chiaramente dimostrano; tuttavia, questa nuova iterazione big budget del supereroe più trucido di sempre non gli rende davvero giustizia. Se l’originale del 1984, fondamentalmente, era una irriverentissima satira slasher, la versione del 2025 si presenta come una commediola di spionaggio aziendale con un po’ di sangue qua e là, più simile alla linea di action figures dedicate a Toxie di Playmates e al successivo cartone animato spin-off, che ha reso Toxie più piccolo e tarchiato (come tutte le figure Playmates), verde invece che marrone e soprattutto un supereroe adatto ai bambini. Il vero Toxie abbatteva la propria furia estrema su chiunque i suoi “tromatoni” percepissero come un cattivo; neo-Toxie, dopo un’iniziale esplosione di violenza, quasi rinuncia a uccidere: desidera più di ogni altra cosa essere un buon patrigno e un modello da seguire, mentre il vendicatore precedente voleva principalmente scopare la sua fidanzata cieca e schiacciare teste. I film Troma sono sovversive follie girate a buon mercato, e questo remake tenta di mantenere il piglio “punk” con un budget maggiore, cosa che gli riesce anche bene. Piuttosto che rifiutare apertamente le scelte estetiche a basso budget, Toxic Avenger prende quei valori produttivi degli anni ’80, nati per necessità, e li amplifica senza mai perderli di vista. Le uccisioni sono artigianali e creative al punto giusto mentre il costume di Toxie, benché verde e più piccolo, è decisamente superiore all’originale, quasi come se Rat Fink si fosse incrociato con una Tartaruga Ninja. Immagina ora invece un film di Toxic Avenger in cui il figlio di Toxie sia abbastanza deviato da stimare il padre per la creatività con cui si prodiga ad ammazzare la gente… ecco, non è questo il caso. Qui il Nostro riceve insopportabili lezioni morali dal ragazzo, si strugge per essere una buona figura paterna, e alla fine ci riesce senza che nessuno, cattivissimi esclusi, si faccia male. Non posso definirlo esattamente un brutto film di Toxie, ma posso dire che non è davvero quello che cerco da un film sul vendicatore tossico. Gore a parte, è un’opera pavida che gioca con la sicura inserita. Lloyd Kaufmanpotrà non avere mai realizzato un film così sontuoso visivamente, ma il film di Macon Blair deve ancora farne di strada per trovare la quadra, quell’urgenza rabbiosa, sovversiva e rinfrescante, l’indomita follia degli originali. Dopotutto se la scena più controversa è una in cui Toxie piscia acido sulle sue cinture di titanio per liberarsi dalla prigionia, qualcosa non va.
recensione di Emiliano Zambon