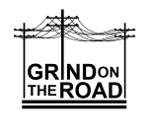Per recensire questo disco ho riscontrato parecchie difficoltà e la colpa è dei Mastodon! Già, proprio la band di Atlanta, che tanto ho amato in passato, ora rappresenta per me un chiodo nella schiena. Ripensando e ricalibrando la loro discografia, sono giunto alla conclusione che i Mastodon importanti, fondamentali, autori di dischi incredibili, sono quelli dei primi due lavori. Poi con Blood Mountain, vero spartiacque per loro, si è inaugurata tutta una serie di coreografia di fuochi d’artificio che, terminati botti e colori, ha lasciato ben poco se non una band fotocopia per troppi anni, troppi album con un sound superficiale, effimero, a tratti noioso (PAT, PAT, un demone mi picchietta sulla spalla e mi ricorda che Crack the Skye è un disco notevolissimo).
Lo so, a questo punto molti lettori avranno smesso di leggere, persi ad imprecare e dannarmi per il resto dei miei giorni. Ma perché affermo che è colpa dei Mastodon se ho penato nel buttare giù una recensione lucida, per quanto possa sembrare il contrario ai numerosi aficionados della band statunitense, con questo secondo disco degli Arcadea? È presto detto: il progetto vede l’ingombrante presenza di Brann Dailor alla batteria e voce. Ed è qui che casca, rovinosamente, l’asino: il suo modo di suonare la batteria è riconoscibile a chilometri di distanza, soprattutto quel malmenare granuloso, lisergico, devoto alla polvere del deserto, che è tipico della svolta stilistica dei Mastodon. Inoltre la sua voce, con quel timbro sgraziato, arricchisce la sensazione di disagio. Avete presente quando sentite un odore che vi rimanda a qualcosa di spiacevole della vostra infanzia? Ecco, Dailor per me è questo, i Mastodon post rincoglionimento sono questo. Mi tengo Remission e Leviathan e sto bene, vado alla grande, e chi mi ammazza? Tornando a bomba, questo album è irritante soprattutto per un aspetto di non poco conto: i brani girano non bene, di più, girano benissimo; ma sempre in quella bolla che vede al suo interno psichedelia, progressive rock, lisergiche fughe strumentali, rapimenti alieni, notti passate a divorare funghi allucinogeni, deserto lunare, deserto terrestre. Sono formalmente perfetti. Proseguono e migliorano quanto fatto nel debutto; la creatura Arcadea, che pare una bestemmia, si evolve, forse non ne ha un vero bisogno, ma personalmente seguita nel risultarmi indigesta. Ma come? Dico che suonano bene ma il disco non mi piace (non dico che mi fa schifo perché non è la verità e sarebbe una sparata fuori luogo)? Certo, avendo qualcosa che funziona all’interno della scatola cranica, riesco a distinguere parecchie cose, una di queste è l’avversione che posso nutrire per un determinato genere, oppure il fastidio nell’ascoltare un musicista con una forte personalità e un sound altamente riconoscibile, senza per questo non riuscire a dare un giudizio lucido e onesto su un album.
The Exodus of Gravity è un lavoro che troverà terreno fertile per chi si nutre abitualmente di certe sonorità, per chi segue la carriera di Dailor (senza dimenticarsi dei suoi compari in questo progetto: Core Atoms, polistrumentista dei Gaylord, e João Nogueira, funambolo di synth e robe elettroniche), forse anche per chi, a differenza del sottoscritto, è meno incline alle menate e al puntacazzismo del lunedì.
(Relapse Records, 2025)
1. Dark Star
2. Exodus of Gravity
3. Fuzzy Planet
4. Lake of Rust
5. Gilded Eye
6. 2 Shells
7. Galactic Lighthouse
8. Starry Messenger
9. Silent Spores
10. The Hand That Holds the Milky Way
11. Sparks
12. Planet Pounder