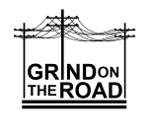Ci sono parole entrate prepotentemente nell’uso comune, parole che l’italiano medio usa a sproposito, se ne gonfia la bocca, andando così a depotenziarne il significato. Per farla breve, certa terminologia ha ampiamente rotto le palle. Una di queste maledette parole è “divisivo”. E devo comunque utilizzarla in virtù di band che hanno spaccato in due il giudizio degli ascoltatori, un team bianco che lotta contro un team nero, senza la presenza di alcuna sfumatura. Mi vengono in mente i Blood Incantation, gli Sleep Token, i Ghost, gli Zeal & Ardor, gli Shining, e tanti altri. A questo insieme possiamo tranquillamente aggiungerci anche i newyorchesi Imperial Triumphant, una band che nel giro di tre lustri e una manciata di album ha contribuito alla diatriba cui ho accennato poco sopra.
Il percorso artistico della band di Zachary Ezrin – da sempre il leader indiscusso – è stato un costante e coerente spingersi oltre. Alla matrice death metal si è aggiunta una forte componente black metal, una spruzzata di grindcore, un paramento free jazz di pregevolissima fattura e una prestigiosa regia avantgarde. La complessità della proposta musicale dei Nostri è proseguita di pari passo con il minutaggio delle singole tracce e con la durata complessiva dei dischi. Quello che si apprezza da sempre nel sound del trio è che l’intricata tessitura compositiva non ha mai inficiato la fruizione dell’ascolto. Complessi, intricati, cervellotici sì, anche abbondantemente; ma mai, ed è qui che risiede la grandezza degli Imperial Triumphant, fine a se stessi, ridonanti, ampollosi. Certamente ogni disco necessita di ripetuti ascolti, di una certa predisposizione a un determinato sound, senza che questo suoni però come un misero discorsetto da elitè autoproclamata, sia chiaro. La musica è una forma d’arte che può anche essere leggera, divertente. Ma nulla ci vieta di vivere un’esperienza diversa, più cerebrale, meno di intuito e di pancia, anche se probabilmente la fruizione avviene a piccole dosi. Già, perché qualsiasi disco del gruppo americano non può esser ascoltato in maniera distratta.
Il debutto Abominamentvm (2012) suonava crudo e diretto, un frutto acerbo, complicato da pulire e gustare, la cui polpa però mostrava già l’organolettica dipendenza per uno stile particolare e, a tratti inedito. Abyssal Gods (2015) era più a fuoco, era il male che serpeggiava per le strade di New York, era la creatura informe che rubava il sonno alle persone ignave. Ricordate? Lo spingersi oltre, alzare l’asticella? Arriva così il turno di Vile Luxury (2018) che è asfissia, che è ninna nanna, che è la fine di qualsiasi tribolazione. La viscosità del jazz comincia a togliere ossigeno, soffoca persino la brutalità primordiale del death metal, la bella e la bestia; da recitare come un mantra: Steve Blanco è IL basso.
Quando sembra impossibile migliorarsi ecco che Alphaville (2020) scompagina qualsiasi nostra certezza. Un anno prima la pandemia, ora un disco che, personalmente, considero l’apice creativo della prima fase della band. Prima fase? Esattamente, un periodo lungo che si andrà a chiudere con il successivo Spirit Of Ecstasy (2022), forse il disco meno riuscito dell’intera discografia targata Imperial Triumphant, ove “meno riuscito” è per il restante 99% delle band un risultato assolutamente non raggiungibile benchè agognato (leggasi: non gliela faranno mai). Con questo lavoro il dedalo compositivo è diventato quasi impossibile da percorrere, nonostante tantissimi brani di una qualità stupefacente. I singoli estratti dall’ep di cover A Night In Tunisia (2023) avevamo preoccupato un pò tutti. La band sembrava essersi persa, musica troppo complicata, esagerata nel voler suonare inaccessibile, brani sfigurati, ostili nel loro riproporsi così differenti rispetto alle versioni originali, persino antagonisti se paragonati ai dischi autografi usciti fino a qualche mese prima. Insomma, il timore che Zachary Ezrin avesse svaccato si stava tramutando in una triste realtà. Ma poi, colpo di scena, l’omicida che non ti aspetti, ecco che esce Goldstar, la mano santa che tutti aspettavamo. Prima cosa: il disco dura quasi venti minuti in meno rispetto ai recenti lavori. Seconda cosa: ricordate quando ho detto che la complessità ha seguito di pari passo il minutaggio ecc ecc? Qui si assiste all’esatto contrario: album che dura poco, trentotto minuti, e un sound che è totalmente user friendly, se mi passate il termine. Certo, la quota difficoltà non è scesa, arduo che gli Imperial Triumphant possano concedersi ad una proposta musicale lontana dal proprio DNA. Ma nell’evoluzione artistica c’è giocoforza anche quella umana, personale, d’animo e di cuore, e quindi ecco che questo nuovo album è la genesi di qualcosa di nuovo, che è la normale prosecuzione di un prima, di un dopo che rinasce da ceneri mai sopite, un volo di Pindaro che riesce a toccare il sole senza danni e fallimenti.
La band è sempre stata molto legata alla propria città, una New York simbolo di crescita, che voleva essere il centro del mondo, forse ci è riuscita per svariati anni, poi il capitalismo sfrenato, l’undici settembre, la rovinosa caduta che nelle Torri Gemelle ha visto il suo diorama. Una città dove milioni e milioni di vite, come formiche sempre di corsa, ne hanno scandito il tempo. Dove sangue e denaro, sporcizia e lusso, arte e depravazione, hanno animato le strade, i club, gli uffici, le metropolitane, 24/7. “Eye Of Mars” apre i discorsi usando toni bellicosi, c’è il death infernale dei Morbid Angel, il sincopatico caracollare dei Portal, poi tanto free jazz, forme libere di improvvisazione, noise, anarchia. Quando le percussioni tribali introducono “Gomorrah Nouveaux” si rimane spiazzati, c’è una mano gentile, tesa verso di noi, ci invita dolcemente ad un ballo alla fine del mondo. Qui Steve Blanco inizia il suo show personale, è lui l’anima che smuove tutto il magma, un pentolone che inghiotte tutto l’universo conosciuto. Ed ecco l’amore viscerale per la Grande Mela, quel mostro tentacolare di acciaio e cemento che tutto avvolge e così è il basso, jazz e fusion, che scalda tutte le tracce del disco, scudisciate salvifiche. “Lexington Delirium”, con la partecipazione di Thomas Haake alle seconde voci, è un omaggio a New York, alla sua architettura; omaggio che graficamente la band ha sempre mostrato nei suoi artwork, tra visioni futuristiche alla Fritz Lang o, come nel caso di Goldstar, all’arte supereroistica di Howard Chaykin, cartoonist nato a pochi km dalla città della Statua della Libertà. Monumento che ha ispirato i nostri per le loro maschere, mentre gli abiti così neutri, direi asessuati, come divinità alle quali non occorre attribuire un genere. Siamo nell’avanguardia più spinta, tutto nasce e muore e si trasforma, la risurrezione delle carni, che diventano metallo, che diventa polvere spaziale. La successiva “Hotel Sphinx” è il naturale prosieguo nella follia controllata, c’è un flusso di coscienza, un loop nel quale perdersi è un toccasana, un allegro peregrinare dentro le assurde prospettive di Escher e mai una città come New York poteva essere lo scenario ideale, il seme e il germe, per una lotta che diventa combutta e infine lussuria tra mito e filosofia. Ma un gruppo come gli Imperial Triumphant non si accontenta mai. “NEWYORKCITY” è la violenza belluina che prende il grindcore, il cannibalismo, le scimmie di Kubrick e ne fa un piatto indigesto da ingollare in 47 secondi, il tempo che serve a Yoshiko Ohara, altra guest del disco, a declamare tutta la sua lucida follia. E si continua con i colpi di scena, la titletrack è un motivetto anni 30, una canzoncina da film comico, in bianco e nero, e qui si torna al “divisivo” posto in apertura, perchè tutto è circolare in questo disco; “Rot Moderne” ci ricaccia a forza in un angolo, piovono sassi tra un singhiozzante death metal e un jazz frenetico. Qui anche Kenny Grohowski sale nell’olimpo, a suggello di una prova dietro le pelli che ha dell’incredibile. Per altro, credo che la batteria sia registrata live, e quel suono così naturale, secco, senza inutili diavolerie tecnologiche, ben si sposa con il suono dei Nostri, un suono che è incredibile come sembri arrivare da tempi antichissimi e pianeti ancora inesplorati. Questa naturale commistione tra sensazioni così diverse trovano il loro palco ideale in “Pleasuredome”, con Dave Lombardo alle percussioni (c’è pure Haake, ma è solo contorno) che porta un calore tutto carioca che sembra non possa centrare nulla con il distacco snob di un jazz sempre col vestito buono della festa. Invece succede l’incredibile, tutto si amalgama, nascono nuove forme di vita, il mondo finisce e tutto rinasce. In meglio, difatti “Industry Of Misery” ne è l’esempio perfetto, un lungo brano, un caleidoscopio, una snowball dove cadono sogni e speranze, un fallout emozionante, come l’assolo di Ezrin, una manciata di note, chiodi nelle carni, chiodi che sorreggono corpi stanchi ma soddisfatti, il sesso estenuante, una gang bang, l’ingordigia e la tossicodipendenza.
Che gli Imperial Triumphant potessero trovare una nuova vita artistica senza snaturare la propria natura era una scommessa sulla quale nessuno avrebbe puntato un centesimo. Personalmente sono sempre stato una pippa con le scommesse. Ma mai come oggi sono felice di aver perso. Goldstar è uno dei dischi più belli che abbia mai ascoltato, nella discografia della band merita di stare al fianco di Vile Luxury e Alphaville, ma poi, lo sappiamo, ci sarà da litigare anche per questo. Che da “divisivo” a “spaccare il cazzo in due” è sempre un attimo.
(Century Media Records, 2025)
1. Eye Of Mars
2. Gomorrah Nouveaux
3. Lexington Delirium (ft. Tomas Haake)
4. Hotel Sphinx
5. NEWYORKCITY (ft. Yoshiko Ohara)
6. Goldstar
7. Rot Moderne
8. Pleasuredome (ft. Dave Lombardo & Tomas Haake)
9. Industry Of Misery