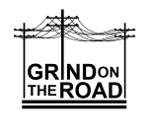Non dovrebbe stupire che il post-rock, in tutte le sue declinazioni, stia trovando sempre più affinità con lo shoegaze. Sono due linguaggi che condividono una vocazione all’evasione, un modo di abitare il suono che dissolve i confini dell’Io, lasciandolo perdersi in feedback ariosi, tremoli sospesi, climax che sembrano mantra emotivi. Se il post-rock spesso rinuncia alla voce per affidarsi all’architettura strumentale, lo shoegaze la lascia emergere in forme diverse: filtrata, impalpabile, quasi irriconoscibile. Si confonde tra le distorsioni, come un ricordo che non si vuole lasciar andare, anche quando inizia a perdere contorno. E tra questi due mondi sonori così affini, gli svizzeri Last Leaf Down sono una delle realtà più interessanti. Attivi dal 2003 tra Basilea e Soletta, nascono come progetto doom metal, ma trovano finalmente la loro direzione nel 2007, con l’arrivo di Benjamin Schenk, oggi voce e penna della band. E pur muovendosi entro coordinate shoegaze, il suo timbro baritonale, che profuma della solennità della cold wave, si impone con naturalezza nelle trame strumentali: è infatti uno dei tratti più riconoscibili della loro estetica, e anche quello che potrebbe spiazzare di più chi si accosta per la prima volta alla loro musica.
Otto anni dopo Bright Wide Colder, ecco dunque Weight Of Silence, il terzo album. È passato molto tempo, e si sente tutto nella profondità del suono: i dieci brani mostrano una band cresciuta nell’intensità, più che nell’evoluzione. Fin dalla copertina, l’immaginario è quello di sempre: foreste immerse nella foschia, colori soffusi, figure umane piccole di fronte alla maestosità della natura. C’è qualcosa di profondamente autunnale nella musica dei Last Leaf Down (come suggerisce, del resto, il loro moniker), senza nulla di arrendevole o decadente: è un po’ come quella bellezza sospesa che accompagna le cose mentre cambiano forma. Assomiglia a quei paesaggi in cui sembra che non stia succedendo granché, e invece tutto si trasforma, anche in modo impercettibile: la luce filtra in modo diverso, le foglie si arrendono alla gravità, l’aria si fa più sottile. E in questo senso, tornando alle sonorità dei Nostri, la malinconia non è affatto una resa, quanto piuttosto una forma alternativa di resistenza all’intensità di certe emozioni. Le composizioni si appoggiano spesso su strutture canoniche, con strofe e ritornelli che le avvicinano a un certo alternative rock. Ma sotto questa struttura lineare si muove qualcosa di più profondo: dinamiche lente, riverberi estesi, crescendo emotivi che le ancorano saldamente al linguaggio del post-rock, nella sua accezione più introspettiva e atmosferica. Il suono è dunque nitido e cristallino, costruito intorno alla voce di Schenk, che resta sempre al centro; le chitarre non la sovrastano, ma la accompagnano con riff puliti e tremoli scintillanti, disegnando uno sfondo dai tratti morbidi e avvolgenti. E in questo tessuto sonoro fatto di attese e aperture improvvise trovano spazio anche momenti più saturi e densi, che aggiungono tensione e pathos, senza mai intaccare la natura sognante delle atmosfere. In brani come “Illusion” o “Reach The Sun”, ad esempio, queste trame si arricchiscono nei bridge, dove le chitarre si intrecciano come rami che si cercano nella nebbia. Il basso ha un ruolo fondamentale: rotondo, presente, guida spesso le progressioni armoniche con una delicatezza quasi materna. La batteria è essenziale, mai invadente, eppure sa diventare protagonista nei momenti giusti. È il caso di “Water”, dove a guidare l’ingresso del ritornello è un pattern marziale, che apre lo spazio a un crescendo catartico, in cui voce e strumenti sembrano fondersi nella stessa onda emotiva. Ci sono, in generale, echi di influenze evidenti: gli Anathema più lirici in “Cold Heart”, un tocco Katatonia nell’inquietudine trattenuta che attraversa tutto il lavoro. Ma anche ombre dei The Cure in “Overtrust”, malinconica e intensa, che trova sollievo nella chitarra distorta del ritornello, senza mai allontanarsi davvero dalla nostalgia. Tra le tracce più sorprendenti mi sento di citare “A Quiet Lost War”: l’incantevole inizio è scolpito su arpeggi che sembrano respirare, mentre la voce affiora delicatamente, come un pensiero che prende forma nella luce dorata di un pomeriggio d’autunno. Più avanti c’è anche spazio per un assolo riverberato, leggero come una scia di luce tra le ombre, che apre uno spiraglio catartico nel muro ovattato del suono. Tutto si muove in equilibrio fragile: la musica avvolge la voce, costruisce trame di grande intensità emotiva e le lascia dissolvere in una dolce resa, come nebbia che si dirada. Non prende per mano, ma resta comunque accanto; e in quel margine incerto ci si può smarrire consapevolmente. Che poi è forse il modo più autentico per ritrovarsi.
Forse è proprio questo il segreto di Weight Of Silence: non si limita a suonare bene, ma riesce a sfiorare qualcosa di inafferrabile e profondo, grazie ad una produzione elegante, ad una cura minuziosa del suono, e soprattutto ad un’intenzione emotiva limpida. Le sue atmosfere sognanti avvolgono e offrono una via di fuga, e questo è forse l’elemento più shoegaze della proposta, più ancora della voce. Al tempo stesso, è anche un disco profondamente post-rock, minuto dopo minuto, tanto nelle armonie e nei fraseggi chitarristici, quanto nella capacità di scavare sotto pelle e concedere spazio ai pensieri. La malinconia che lo attraversa non è mai passiva o fine a sé stessa: vibra di una sincerità che sfiora la pelle, ma non la ferisce. È una malinconia che cura, non che consuma, a tratti quasi terapeutica. I testi non offrono risposte, ma immagini di fragilità, dolori trattenuti, delusioni sussurrate. Eppure, come i raggi di luce che filtrano tra le foglie, persino quando cadono – komorebi, direbbero in Giappone – trovano sempre una via per farsi bellezza.
(Lifeforce Records, 2025)
1. Silence
2. Cold Heart
3. Reach The Sun
4. Illusion
5. Water
6. Falling Sky
7. Overtrust
8. A Quiet Lost War
9. The Ending
10. Mislead7.5