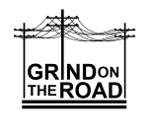VIDEO NASTY è un termine coniato in Inghilterra negli anni 80 dal comitato censura per indicare i film da VHS che avevano un contenuto violento o comunque mal visto.
Questa nuova rubrica parla di cinema ed è a cura di Carmelo Garraffo ed Emiliano Zambon.
Se vuoi proporci un film da recensire o collaborare con noi, scrivi a redazione@grindontheroad.com

PRESENCE di Steven Soderbergh (2024)
Uscito il mese scorso nei nostri cinema, l’ultimo film di Soderbergh ha, per me, un problema non da poco che riguarda il marketing. È stato presentato come un horror, di quelli che nel trailer usano paroloni che ti dicono a più riprese che è arrivato il film più terrorizzante di tutti, uno sbaglio che sicuramente ha portato diversi spettatori a rimanere delusi dal film. A leggere in giro infatti i commenti sono molto diversi, da chi lo ha amato a chi no e, ripeto, il motivo per me sta tutto nel marketing perché il film è molto buono. Ammetto che guardando i primi trailer diversi mesi fa anche io mi ero galvanizzato all’idea di vedere un bel horror di Soderbergh che è in realtà, per me, un regista altalenante che ha alternato progetti super ok e altri che sinceramente ho evitato come la peste. Però, va detto, è un regista tecnico, di quelli che sa come si fa il cinema e le premesse erano più che positive. Presence ci viene presentato come un horror in prima persona dove la prima persona è un fantasma. Quindi movimenti nel buio, persone spiate, una grande casa e pochi personaggi. Poi, prima di vedere il film, ho cominciato a pensare che il fantasma potesse essere solo un osservatore di un dramma familiare che nulla avrebbe avuto a che fare con l’orrore che ci avevano promesso. La verità, in realtà, sta un po’ nel mezzo. Il punto di vista del fantasma, oltre ad essere un idea visiva che permette al film di volteggiare tra gli spazi e i personaggi in un modo registicamente molto interessante, è più protagonista rispetto alle mie aspettative, anzi, è alla fine centrale. La storia non è principalmente un dramma, anche se all’inizio lo può sembrare ma, piano piano, esattamente come le movenze della presenza, si trasforma e si comincia a capire che siamo più dalle parti del thriller, che è una cosa che non mi aspettavo. Ma, va ripetuto, non si arriva mai dalle parti dell’horror vero, nonostante alcune volte ci vada vicino per via dell’uso di alcuni meccanismi. Il film, quindi, è ben girato con le giuste atmosfere e dei bravi protagonisti che riescono a imbastire a colpi di piccoli indizi una trama che alla fine andrà a dipanarsi e a risolversi. E se siete persone un minimo sensibili su questi temi, e siete stati attenti, alla fine il film potrebbe persino commuovervi lasciandovi all’inizio dei titoli di coda un po’ sospesi e malinconici, come la presenza del film. Promosso.
recensione di Carmelo Garraffo
 ADOLESCENCE di Jack Thorne, Stephen Graham (2025)
ADOLESCENCE di Jack Thorne, Stephen Graham (2025)
Se siete un minimo appassionati di serialità televisiva siete sicuramente imbattuti in qualcuno che parlava di questa nuovissima serie targata Netflix creata e recitata (anche) da Stephen Graham, che alcuni ricorderanno per la presenza nel film e nella serie di This is England (ma che ha una lunghissima carriera). In giro ne leggerete benissimo, con aggettivi che la descrivono come una delle migliori serie Netflix in circolazione. Anche qui, come per il film recensito qui sopra, la verità sta un po’ nel mezzo. Siamo sicuramente davanti a una buona serie televisiva con dei picchi molto alti che però non mantiene per tutta la sua durata. La cosa che colpisce subito, nel primo episodio (di quattro) è il modo in cui è girata. Ogni puntata è infatti girata con un unico e lungo piano sequenza che segue i personaggi senza staccare mai creando tutto un dinamismo particolare e molto bello da vedere. È un ottima idea visiva che dà carattere alla serie ma va detto che non è un qualcosa che serva realmente, o almeno non serve sempre. Se infatti in alcuni momenti, soprattutto all’inizio, la tecnica riesce a immergerci nell’azione e in quei primissimi minuti di tensione riuscendo a farceli vivere secondo dopo secondo con l’ansia giusta, andando avanti con gli episodi si ha la sensazione che l’uso del piano sequenza sia messo li per far dire allo spettatore “oh wow, guarda che è girato tutto insieme. Bravi!” che è vero, ma non sempre è davvero utile. Soprattutto se teniamo conto che la serie è un po’ discesa e la storia si perde un pochino. Non diventa mai realmente brutta anche perché ha qualcosa da dire, fino alla fine, e diverse prove attoriali, date anche dalla gabbia del “piano sequenza” molto buone, a partire dal piccolo attore protagonista di un paio di episodi fino ad altri, protagonisti assieme a lui di altri episodi (su tutti la psicologa del terzo episodio). Rimane una serie che consiglio per diversi motivi, anche solo per come è realizzata, e che riuscirà in qualche modo a far discutere e riflettere su alcuni temi, che non è mai scontato. È vero che una delle migliori serie Netflix del momento ma va anche detto che lo è anche perché negli ultimi tempi Netflix ha molto abbassato la qualità delle proprie produzioni. Non credo sia un capolavoro ma è un qualcosa che consiglierei a chi ha voglia di vedere una serie un po’ più impegnativa.
recensione di Carmelo Garraffo
 TETSUO di Shin’ya Tsukamoto (1989)
TETSUO di Shin’ya Tsukamoto (1989)
Perché stiamo parlando di Tetsuo (The Iron Man) nel 2025? È presto detto. Il capolavoro del regista giapponese Shin’ya Tsukamoto arriva per la prima volta nei cinema italiani ed è sicuramente una cosa da segnalare a chiunque sia amante del cinema e del regista. Non solo Tetsuo ma anche molti altri film della sua filmografia, ovvero Tetsuo II, Tokyo Fist, Bullet Ballet, A Snake of June, Vital, Kotoko, Zan e Hokage. Nove film in giro per l’Italia a partire dal 7 Aprile. Aprite internet e cercate le sale più vicine a voi che li proiettano! Per chi non sapesse cosa sia Tetsuo (quindi nessuno, spero) stiamo parlando del film che ha inventano un certo tipo di cyberpunk, quello sporco e malato che ha indelebilmente segnato la mente di chiunque lo abbia visto, mettendo le basi per tutto un genere che da lì in poi si sarebbe sviluppato. Non è un film né facile né commerciale, ma un piccolo gioiello indipendente in bianco e nero sperimentale tutto matto. È complicato parlare della trama di Tetsuo, per via della sua struttura, ma soprattutto perché è sicuramente qualcosa che fa metafora di una società, quella giapponese, che a guardarla bene sembra un po’ tutto il mondo col suo (come dicevano i Sottopressione) “distruggersi per poi risorgere”. Su wikipedia la trama è un spoiler unico perché ricostruirla piano piano è uno dei tanti meccanismi che lo spettatore si troverà a innescare durante la visione, come un puzzle da decifrare, che fa parte integrante dell’esperienza. Possiamo però dire senza rovinarvi la visione che il film inizia con un uomo che scopre di star piano piano mutando in una macchina, con ingranaggi e tutto il resto che crescono sempre di più, alterando il suo corpo. Famosa la scena di lui che con un pene enorme a forma di fresa gigante penetra e uccide la fidanzata, tutto questo senza essere davvero trash. Il film ha ovviamente molto altro, dai simbolismi, come dicevamo, a tutta una serie di trovate tecniche e visive che danno alla pellicola un aspetto e un’atmosfera che non troverete altrove. Le tematiche sono sicuramente quelle della trasformazione dell’uomo in relazione al mondo e alla società che lo circonda. I parallelismi con un certo Cronenberg si possono tranquillamente fare, anche perché lo stesso Tsukamoto ha più volte dichiarato il suo amore per il regista canadese. Insomma Tetsuo è, come detto in apertura, un capolavoro da guardare e riguardare, magari al cinema.
recensione di Carmelo Garraffo
THE MONKEY di Oz Perkins (2025)

Se Longlegs si presentava come qualcosa di assolutamente fresco e rivelatorio nel panorama horror recente, il nuovo lavoro di Oz Perkins, un libero adattamento di un breve racconto di Stephen King dal titolo omonimo, risulta a tratti un po’ sciatto, un pastiche mai davvero coeso. La cosa più frustrante è che a Perkins il senso dell’umorismo non mancherebbe, e ha sicuramente avuto l’intuizione giusta nell’abbandonarsi alla stupidità intrinseca della storia. Tuttavia, l’estrema serietà con cui improvvisamente sceglie di trattare certi passaggi apre a un tono via via sempre più ballerino e casuale che sembra non decidersi mai in quale corsia sistemarsi. E una sceneggiatura che sembra sostenere che l’unica cosa che possiamo fare di fronte alle nostre paure più esistenziali sia ridere, perde tutto lo slancio quando tutto l’umorismo e il divertimento finiscono fagocitati da un pervasivo, serissimo cinismo, giungendo a una conclusione che è in qualche modo troppo disordinata e troppo debole. Più di molti altri mashup di generi, le commedie nere richiedono mani ferme al volante per non scivolare nella farsa o nell’eccessiva serietà, e Perkins sulle prime sembrava esattamente il tipo di talento che avrebbe potuto cavalcare quella linea così sottile. Invece, questo tentativo riuscito a metà ci lascia per lo più con l’amaro in bocca per tutte le opportunità mancate; da un world building interessante ma dispersivo a scelte di regia e montaggio grevi che si rifiutano di unirsi a un tutto coeso e coerente mentre Perkins, al netto di una manciata di personaggi secondari, fatica persino a popolare questa storia di protagonisti interessanti o colorati. “Tutti muoiono, questa è la vita” è un ritornello costante per tutti i 98 minuti. Nel contesto del film, quella che sembra inizialmente un’osservazione banale è in realtà pensata per risuonare come una profonda consapevolezza. L’inevitabilità e l’imprevedibilità della nostra fine non sono una buona scusa per mollare, anzi, dovrebbe essere esattamente ciò che ci motiva a continuare a fare del nostro meglio. È un peccato dunque che l’esecuzione di argomenti così forti lasci tanto a desiderare. Alla fine The Monkey si rivela una corsa imbevuta di occasionali risate e violenza spesso creativa e divertente che tuttavia non trova mai la quadra per conciliare nessuno dei suoi ingredienti.
recensione di Emiliano Zambon
 HEART EYES di Josh Ruben (2025)
HEART EYES di Josh Ruben (2025)
È un film pensato per mettere tutti d’accordo Heart Eyes: ai single offre la soddisfazione di vedere morire male quelle coppiette in fissa con i social, o che si sbaciucchiano in pubblico e per poco non si risucchiano le budella, mentre per quelli di voi che invece una relazione ce l’hanno, presenta una simpatica storia d’amore con le idee più uniche per un primo appuntamento (dare la caccia a un serial killer > pizza e cinema). Il romanticismo è morto e nessuna coppia è al sicuro. Il killer dagli occhi a cuore, un cugino di Jason Vorhees ma senza “mommy issues”, perseguita e trucida le coppie a San Valentino. È una semplice premessa in cui una ragazza delusa dalle relazioni e un ragazzo alla ricerca del vero amore si incontrano nel bel mezzo dell’eccidio di coppiette: è divertente, è scemo, piuttosto creativo e certe uccisioni mi hanno parecchio divertito. Heart Eyes è senza dubbio una delle più simpatiche rom com che abbia visto di recente. Uno slasher, certo, ma uno che si intreccia abilmente ai tropi romantici (e non solo). Qua e là sbava e sembra un po’ incerto sull’equilibrio tra i vari registri, ma per un film che non vuole essere preso troppo sul serio, questa è una miscela di romanticismo e orrore pressoché perfetta.
recensione di Emiliano Zambon
 CURE di Kiyoshi Kurosawa (1997)
CURE di Kiyoshi Kurosawa (1997)
Negli anni Novanta Kiyoshi Kurosawa è stato, insieme a Hideo Nakata e il suo Ringu, Takashi Shimizu con Ju-On e Takashi Miike con Audition, un punto di riferimento per l’horror giapponese nel mondo occidentale. L’esplorazione di Kurosawa del terrore esistenziale però non presenta ragazze pallide con viticci di capelli neri che escono dai televisori o strisciano giù per le scale, né alcun segno della macelleria grafica che piace tanto a Miike. Cure è più sottile, più subdolo; si occupa dei mali ininterrotti della società moderna e delle loro umanissime origini. È la riflessione oracolare di Kurosawa dei modi in cui il sistema ci porta a reprimere la nostra naturale inclinazione alla violenza, in cui il libero arbitrio è solo una chimera, un’idea, la falsa promessa di comfort e controllo in un mondo governato dal caos in cui la violenza è un impulso inscindibile. Non importa quanto cerchiamo di sopprimere, ignorare, dominare e controllare ciò che è parte intrinseca della nostra natura primordiale, l’impulso a infliggere dolore e distruggere si libera dai nostri costrutti morali facilmente come accendere un accendino. Cure si prende i suoi tempi, rivelandosi gradualmente come qualcosa di più sfuggente, più insolubile di “colleghi” americani come Il Silenzio degli innocenti e Se7en, con i loro sagaci maniaci che snocciolano erudite motivazioni ai loro bisogni. Nessuna diatriba qui, nessun ego ipertrofico, nessuno che pontifica di imprese grandiose. La violenza è come una malattia che passa da persona a persona, un infinito Ouroboros di morte. Il killer di Cure non è particolarmente interessante; è solo il prodotto di innumerevoli sistemi e macchinazioni, come tutti noi, uno dei tanti. È la progenie dell’inevitabile corruzione umana, la violenta inevitabilità dell’identità repressa del Giappone. Un film allo stesso tempo intimo e piccolo, ma enorme nelle sue implicazioni. Il pacato e sereno chiacchierare del killer esuma le violente inclinazioni delle persone che ribollono sotto la facciata che adottano per condurre delle vite banali. Il film è intriso di una qualità enigmatica che si compone di un’economia architettonica che ricorda Yasujirō Ozu favorendo sguardi statici da distanze medie o lunghe, spesso svuotate dello sfondo, come se non esistessero altro che i soggetti. La luce naturale del sole inizialmente copre tutto, con ombre minime, sale anonime e corridoi banali nel loro candore, una strana estetica per un horror. Ma una volta che i due protagonisti si incontrano, nella tenebrosa lavanderia del seminterrato di un ospedale, la delicata intelligibilità del giorno viene consumata dall’oscurità, l’unica fonte di luce proveniente dalla punta fumante di una sigaretta, e dalla fiamma di un accendino. Saranno le ombre a dominare la scena, ombre e sibili che filtrano da edifici fatiscenti. L’aria si fa fetida, il nulla e gli spazi aperti raramente ci sono sembrati così alienanti e claustrofobici. I giochi di trama e di forma si compongono in un intrigante puzzle psicologico ed esistenziale, un mistero soprannaturale che indaga allo stesso tempo una serie di omicidi, una trascendenza e possibilmente una proiezione emotiva ambivalente e restia a trovare una chiusura, sia in termini narrativi che di forma. Questo è cinema sofisticato e personale che sfida ogni etichetta convenzionale. Anche se sembra e, a volte, si sente un poliziesco procedurale e in parte anche un horror, Cure porta a domande essenziali su ciò che obbliga le persone a comportarsi in un certo modo, quali versioni di noi stessi siano reali e come, attraverso tale incertezza, possiamo mai sperare di trovare la quadra nella nostra vita a tali domande che persistono nel nostro subconscio. Arriva nelle sale italiane per la prima volta il 3 Aprile e se ve lo perdete siete matti.
recensione di Emiliano Zambon