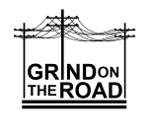VIDEO NASTY è un termine coniato in Inghilterra negli anni 80 dal comitato censura per indicare i film da VHS che avevano un contenuto violento o comunque mal visto.
Questa nuova rubrica parla di cinema ed è a cura di Carmelo Garraffo ed Emiliano Zambon.
Se vuoi proporci un film da recensire o collaborare con noi, scrivi a redazione@grindontheroad.com
 OPUS di Mark Anthony Green (2025)
OPUS di Mark Anthony Green (2025)
Che confusione. Opus vuole entrare nel filone portato alla ribalta da Midsommar, poi da The Menu e poi da Blink Twice, ovvero: gruppo di persone va in un posto isolato dove la comunità è tutta matta. Non è uno spoiler perché a differenza degli altri film citati lavora talmente male che lo capisci al secondo uno (o forse taglia la testa al toro senza nasconderlo) e il film dura un’ora e quaranta. È ben fatto e ci sono un sacco di buoni attori ma ha il problema di non aver capito un certo tipo di film che ha di certo radici molto più profonde di Midsommar, andando a riprendere tutto un filone folk horror che non lo so, dico Wicker Man? Fate voi, ci siamo capiti. Ma se lì era tutto un seminare per creare un background dietro alla storia principale, qui ci sono un sacco di pretesti e forzature di cose strane che succedono solo perché sono strane, senza una reale spiegazione sul perché sia così. Sono semplicemente in un luogo dove questa “setta” ha comportamenti e usi bizzarri in un certo modo perché si. In realtà ci sono un paio di momenti in cui cerca di unire dei puntini (uno di questi è uno spiegone noiosissimo) ma tutto si muove tra il banale e il “guarda che idea pazzesca” che in realtà non lo è. Sicuramente l’intenzione era di farne una versione più pop e grottescamente leggera ma non sembra funzionare mai, sembrando più che altro stupida e appiccicata per rispettare delle regole del genere che non sembrano interessare davvero (e allora fai un altro film, dico io). Per non parlare del doppio finale dove vorrebbe stupirci con un colpo di scena che “wow raga ma hai capito?!” che invece non lo so, a me non ha colpito particolarmente. Nonostante questa mia recensione sembri un invettiva molto cattiva in realtà si arriva comunque alla fine, il film mantiene un certo ritmo e si fa guardare anche grazie ad alcune scene di sangue e al cast variegato. Forse il problema principale è che si è cercato di commercializzare in salsa super pop e accessibile un genere che di regola è fatto di piccole cose e brutte sensazioni che ti scorrono dietro la schiena e nonostante porti a casa la visione ci si sarebbe aspettato qualcosa di un po’ più profondo e complesso. A me non ha colpito molto a fondo ma magari fa per voi.
recensione di Carmelo Garraffo
825 FOREST ROAD di Stephen Cognetti (2025)
Bisogna fare una piccola premessa per parlare di 825 Forest Road. Sapete chi è Stephen Cognetti? È un regista che si è fatto conoscere da una piccola nicchia di appassionati per una saga horror chiamata Hell House LLC che ha come plot: “giovani occupano una casa abbandonata con la malsana idea di trasformarla in una casa degli orrori e farci entrare dentro la gente a pagamento”. Non siamo dalle parti della fama di Saw né da quella meno prodotta di Paranormal Activity ma parliamo di film a basso budget che (in teoria) si dovrebbero muovere principalmente grazie alle idee. Non è roba che esce in sala (non solo da noi), distribuita più che altro su piattaforme digitali che trattano il cinema horror. Shudder è il canale di riferimento che, ahimè, da noi non è presente (ma se sapete come muovervi nei meandri della rete questi titoli non sono così difficili da reperire). Tagliando corto non è che sia una saga dalle grandi qualità, ma tra “medi e bassi” ne sono usciti quattro (con un quinto in arrivo) e tutti rientrano nella categoria dei found footage. 825 Forest Road è il primo film di Cognetti a non usare questa tecnica, prediligendo riprese più tradizionali, e se lo chiedete a me, che un po’ ai suoi film precedenti mezzi brutti e strampalati si era affezionato, era una bella prova sul campo, un’occasione per fare un salto, o almeno un saltello. Purtroppo, ahimè, la prova non è stata superata e 825FR (abbreviamo) non solo non porta avanti Cognetti come regista ma, anzi, lo fa tornare indietro con un’opera che più che opera quinta sembra un’opera prima, il che è strano perché il film precedente era il suo film girato meglio e la sensazione era che piano piano potesse uscire fuori come un regista da tenere in considerazione per quelle serate da horror da cestone che non ti chiedono di usare un grammo di cervello. Qui Cognetti oltre a girare male (la scena che spaventa di più è quella con la soggettiva da un telefono, pensate un po’) scrive anche peggio con una di quelle storie che vorrebbe essere complessa ma lo è solo perché gestita malissimo, con una risoluzione finale che non ha senso e significato da qualsiasi parte la si guardi. La storia è più o meno questa: moglie, marito e sorella traumatizzata di lui vanno a vivere in una nuova casa che forse è posseduta da qualcosa. L’idea del film è di dividerlo in tre, seguendo il punto di vista dei protagonisti. Il risultato sono ribaltamenti di punti di vista molto pigri che finiscono per unirsi nel finale dove il mistero viene finalmente ricostruito e svelato. In una rubrica piena di consigli a questo giro vi do uno “sconsiglio” che è un po’ una scusa per parlarvi dell’esistenza di Hell House LLC in attesa del nuovo capitolo di cui, sicuramente, avrò modo di parlarvi più avanti. Poi chissà, magari vi ho comunque messo una pulce nell’orecchio su qualcosa che prima non conoscevate.
recensione di Carmelo Garraffo
 Or Utopia di Yunsoo Kim (2024)
Or Utopia di Yunsoo Kim (2024)
Passato assolutamente sotto silenzio Or Utopia è un film giapponese disponibile da noi su prime video che vale la pena recuperare. È difficile parlarne senza fare spoiler, soprattutto perché a leggerne la sinossi in giro ci si incappa subito. Siamo nel 2024 e succede qualcosa al pianeta Terra che costringe un piccolo numero di persone a rimanere all’interno dell’hotel in cui stavano soggiornando per i motivi più vari. Fuori, nel mondo, si scatena qualcosa che lo sta distruggendo. Non è tanto importante quello che succede fuori ma quello che succede dentro perché, nonostante le premesse possano farlo pensare, non ci troviamo di fronte a un film post-apocalittico di stampo action o mistery. Parlare di “quello che succede dentro” è in questo caso interpretabile in diversi modi, sia a livello puramente di sopravvivenza e di rapporti tra i personaggi ma anche in relazione ai personaggi stessi che dovranno scendere a patti con il loro Io e con i motivi per cui si trovavano in quell’hotel. Ci troviamo quindi di fronte a un film di scrittura, di dialogo, di rapporti, che indaga sull’esistenza. Per fortuna non lo fa in un modo banale e va detto per correttezza che se state cercando un film dal grande ritmo e colpi di scena forse non è il film adatto a voi, ma se amate i film particolari, magari un po’ contemplativi, che possano parlarci di “noi”, allora Or Utopia è un buon consiglio di cinema. Non un capolavoro ma un buon film non per tutti ma oh, il cinema fatto per tutti non è mai il cinema migliore.
recensione di Carmelo Garraffo
 SINNERS di Ryan Coogler (2025)
SINNERS di Ryan Coogler (2025)
La carriera di Ryan Coogler si è arenata nei franchise per oltre un decennio, forse a causa della forza con cui si è fatto sentire grazie a progetti come Creed, o attraverso il peso soffocante della sinergia aziendale di Black Panther. Il suo nuovo lavoro arriva dunque come una sorta di liberazione, la prima sceneggiatura originale dal 2012, una che prende le lezioni di John Carpenter e Spike Lee e le mescola nella sua anarchica riflessione sull’arte e la cultura nera. È la rara produzione mainstream di genere che pungola l’intelletto mentre ti destabilizza con una serie di cambi di stile e tono così improvvisi e poco convenzionali che è davvero bello vedere Coogler così libero di giocare con la tecnica e affrontare le idee politiche come vuole, mentre percorre elegantemente la sottile linea tra intrattenimento e un senso di tragedia imminente attorno al fascino e all’azione del vampiro. Perché la tentazione è palpabile: di una vita libera da un tempo e un luogo in cui la sicurezza non è mai garantita così come la libertà dalla repressione della chiesa e dall’oppressione dell’egemonia bianca. Sinners assembla pazientemente il suo cast, lasciando ampio spazio per introdurre ed esplorare completamente le psiche e i retroscena dei suoi personaggi e li segue mentre cercano di plasmare i loro sogni nella desolante realtà del sud dell’era Jim Crow. Una storia ampia e allegorica sull’America, sulla musica, sull’appropriazione culturale e sui miti che ci raccontiamo sulle origini dei grandi artisti. C’è una discussione sulle contraddizioni della segregazione afroamericana: una disumanizzazione di chiunque sia ritenuto indesiderabile, unita a un’invidia della loro cultura. In questo contesto, i vampiri sarebbero una sorta di allegoria della Jim Crow, ma anche evocativi di una relazione parassitaria di lunga data tra musica nera e opportunisti bianchi. In questo senso, lavorare sotto questo tipo di sistema sembra davvero un patto con il diavolo – e sebbene Sinners non sia così scontato da fornire una “risposta” corretta alla sua interpretazione, è liberatorio vedere i modi in cui Coogler presenta l’industria come qualcosa che si nutre del sangue dei suoi artisti. In qualche modo, tutta questa roba si adatta perfettamente in un film che è contemporaneamente spaventoso, affascinante e divertente. E quando finalmente inizia lo spargimento di sangue, Coogler ha esplorato questi personaggi così a fondo – e il cast ha investito nei propri ruoli così tanta umanità – che è ancora più straziante vederli perire. La mia unica lamentela: Coogler fa un lavoro così magistrale nel ritardare l’orrore, prolungare la situazione di stallo e tensione latente per tutto il film che la resa dei conti, l’inevitabile scontro tra i sopravvissuti e i vampiri arriva in modo un po’ troppo brusco, prevedibile e anticlimatico. Ma non è il peggior peccato del mondo. E il modo in cui Coogler risolve le idee centrali all’interno di una tradizionale struttura da horror soprannaturale è davvero notevole. Avercene.
recensione di Emiliano Zambon
 THE RULE OF JENNY PEN di James Ashcroft (2024)
THE RULE OF JENNY PEN di James Ashcroft (2024)
A mio avviso, i migliori horror sono quelli disposti a rischiare -anche a costo di sbagliare- nel perseguimento di una certa personale visione. Quei film disposti a grandi oscillazioni, ad allontanare grandi fette di pubblico mentre spingono pochi scelti a innamorarsi. Come nel caso di The Rule Of Jenny Pen, il trattato di James Ashcroft sull’invecchiamento e sulla crudeltà con due straordinari vecchi: un roccioso Geoffrey Rush e un John Lithgow in gran spolvero alla prova con una delle più straordinarie performance della sua carriera, una che gioca perfettamente sui suoi punti di forza, a cavallo tra il matto dagli occhi morti di un tempo e il veterano gentile che è ora. Il film evita qualsiasi ambiguità sul suo stato mentale e ce lo presenta rapidamente per quello che è: un presunto paziente di demenza che vaga di notte tra i corridoi dell’ospizio che lo ospita in compagnia di un burattino di nome Jenny. Un vecchio manipolatore sadico abbastanza fortunato da godere invece di buona salute, che si ritrova nella posizione di poter sfogare la frustrazione accumulata in una vita di delusioni con deliziosi atti di crudeltà gratuita nei confronti degli altri residenti, e di chiunque sia abbastanza temerario da provocarlo. Per buona parte del film, Ashcroft ottiene con successo una sorta di profondità pulp, sfruttando l’overacting di Lithgow come cavallo di Troia per una esplorazione più sobria dell’età e del potere. Bilanciare due toni tanto differenti però può essere una sfida, e benché spesso il film riesca a sposare con successo sobrio e grottesco, ci sono momenti in cui sembra incerto su quale versione dovrebbe prevalere, vacillando un po’ troppo nel tentativo di tenere insieme le cose quando conta di più. Però quando funziona – quando attinge alla vera ingiustizia dell’invecchiare – The Rule Of Jenny Pen rappresenta il tipo di swing che vorresti vedere più spesso dai moderni cineasti horror. Come dice il proverbio, “nella terra dei ciechi, l’uomo con un occhio solo è il re”, e Jenny Pen mostra cosa può accadere quando un bastardo con un grande potere resta impunito. Possa ognuno di noi avere già due piedi nella fossa prima di sperimentarlo di prima mano.
recensione di Emiliano Zambon

IN MY MOTHER’S SKIN di Kenneth Dagatan (2023)
L’anno è il 1945 e i giapponesi occupano ancora le Filippine. Mentre osservano un soldato giapponese e un collaboratore filippino introdursi in casa accompagnati dal padre, una sorella racconta al fratello una storia che ha sentito circa un giapponese che ha trafitto un bambino con la baionetta senza fare una piega. Vi sono atrocità ovunque, e l’innocenza non è di casa. Il padre si allontana per una missione segreta, forse senza ritorno, e presto anche la madre si ammala, lasciando sorella e fratello vagare nella giungla circostante in cerca di cibo. È lì che la ragazza trova una potenziale soluzione a tutti i loro problemi, una fata misteriosa che la esorta a curare la madre con una strana medicina. Quello che segue è un horror piuttosto brutale e molto ben fotografato, in cui ogni immagine e sequenza viene elaborata con grande cura e attenzione. Purtroppo, in guerra non solo si perde l’innocenza, ma gli innocenti vengono brutalizzati, e questo, più di ogni cosa, è ciò che si rivela davvero difficile da digerire nel film di Kenneth Dagatan, benché in linea con le atrocità che infliggiamo quotidianamente al mondo e a cui sembriamo anestetizzati. Il suono e l’immagine lavorano in tandem per un risultato potente, inquietante e orribile. Nessuno può sfuggire al vizioso sadismo dell’homo sapiens e la nostra fata che si nutre di carne umana è qui per ricordarcelo. Ma Dagatan non feticizza mai la cattiveria, la sua macchina da presa è un semplice testimone di tutto ciò che può andare storto in questo esperimento visivo chiamato vita.
recensione di Emiliano Zambon