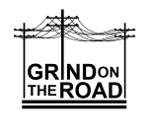Con A Single Flower, i We Lost The Sea tornano a esplorare il dolore, scegliendo ancora una volta di attraversarlo a occhi aperti. Lo suggerisce già la copertina: la sagoma nera di un corvo, trafitta da un fiore rosso, è la sintesi visiva di un disco che contempla le rovine di una società al collasso, lasciando che qualcosa di fragile e luminoso prenda forma proprio dove tutto si sgretola. Dopo il capolavoro strumentale Departure Songs (2015), ormai entrato nell’immaginario collettivo del genere, e il cupo Triumph & Disaster (2019), che anticipava di un anno la pandemia e sembrava già intuire l’angoscia di un mondo sull’orlo del baratro, A Single Flower sceglie di addentrarsi nell’abisso della devastazione e di ascoltarne i sussurri. In un mondo che ha smarrito ogni certezza, questo nuovo lavoro è la colonna sonora ideale per l’inquietudine di chi continua a chiedersi cosa possa ancora restare in piedi mentre tutto intorno crolla.
Si comincia con “If They Had Hearts” e il suo fraseggio di chitarra ciclico, che all’inizio sembra quasi inoffensivo. Ma ad ogni ripetizione della melodia l’aria si addensa: i suoni si sovrappongono lentamente, come nuvole cariche di elettricità, e l’atmosfera diventa sempre più claustrofobica. Poi entra la batteria di Alasdair Belling, alla sua prima prova in studio, e il brano si stringe in una morsa che toglie il fiato, finché tutto si comprime in una spirale opprimente. E proprio nel punto in cui sembra impossibile uscirne, arriva una calma improvvisa e si torna a respirare: poche note di pianoforte si insinuano come bagliori nella nebbia, mentre una chitarra in tremolo vibra in lontananza. È il primo segno del piccolo fiore che resiste ostinatamente, mentre fuori infuria la guerra e la cenere oscura l’azzurro del cielo. “A Dance with Death” porta la tensione ancora più in alto, con i suoi dieci minuti sorretti da un basso saturo e monolitico e da uno dei riff di chitarra più magnetici del disco, che pare contorcersi per sfuggire a una forza invisibile. Man mano che il brano avanza, tutto si fa più incandescente; le chitarre ribollono come magma sotto la superficie, la batteria martella senza tregua e l’esplosione sembra inevitabile. A metà, però, il pezzo si apre ad un interludio rarefatto, vicino all’atmosfera di “Bogatyri” su Departure Songs: gli accordi di chitarra si fanno minimali, mentre note di piano e piatti appena sussurrati, dal vago respiro jazz, concedono un breve attimo di tregua. Poi l’onda torna a sollevarsi minacciosa in un finale pesante che ricorda la furia post-metal di Cult of Luna e Russian Circles e che spazza via ogni appiglio. Quando anche questa forza si estingue resta una quiete irreale; nel silenzio, ancora caldo di cenere, torna la melodia iniziale, scura come lava rappresa, e sembra quasi che si porti addosso le cicatrici di tutto ciò che ha attraversato. “Everything Here Is Black and Blinding” descrive bene l’ossimoro del titolo, alternando momenti di inquietante desolazione slowcore a lampi improvvisi di intensità più drammatica, con riverberi cupi che avvolgono persino la batteria, oltre che le chitarre. E mentre i suoni eterei circostanti dipingono questa atmosfera spettrale il crescendo delle percussioni si fa sempre più incalzante, con una sorta di cadenza ipnotica in chiusura che mi ha ricordato la corsa inarrestabile di “Popplagið” dei Sigur Rós. Con “Bloom (Murmurations at First Light)” invece la rotta cambia: una chitarra solitaria apre uno spiraglio di luce, ma viene subito travolta da un muro del suono quasi apocalittico che abbatte ogni difesa. Il basso, con una saturazione che strizza l’occhio allo sludge, scava crateri sotto il mix; nel mentre Belling firma uno dei pattern di batteria più incisivi dell’album, tra accenti tribali, pause misurate e ripartenze dal sapore progressive. Dopo l’esplosione, la tempesta si placa in due fenditure: prima un groove luminoso con chitarre limpide, poi una commovente foschia di pianoforte che sembra lontana anni luce, eco delle malinconie glaciali di The Earth Is Not a Cold Dead Place degli Explosions in the Sky. Ma ecco che le chitarre si serrano ancora, la batteria accelera e l’irruenza post-metal torna a divampare; al culmine della deflagrazione però si dissolve tutto, e dal caos ritorna la stessa chitarra serena che aveva aperto il brano. E ancora una volta quel fiore delicato continua a filtrare vita tra i detriti, mentre gli ultimi echi di delay si spengono come braci sotto la cenere. “The Gloaming” è respiro puro: il violino di Sophie Trudeau (Godspeed You! Black Emperor) intesse un lamento d’archi su note sparse di piano, aprendo la strada alla gigantesca “Blood Will Have Blood”: ventisette minuti di immersione totale, per un’esperienza che contiene al suo interno due climax ben distinti. Più che una suite è una specie di microcosmo che risucchia tutto il disco e lo risputa trasfigurato, una vera e propria odissea sonora dai mille volti. Nella prima metà convivono melodie struggenti dal respiro cinematografico e squarci luminosi alla This Will Destroy You, con le percussioni che evolvono in una marcia inarrestabile, che mi ha fatto pensare al climax catartico di “Challenger Part 1 – Flight” di Departure Songs. Ma la luce dura poco. I contorni si deformano, la calma arretra dinanzi ad una nuova inquietudine che sposta gli umori altrove: marce solenni di batteria, fraseggi malinconici e decadenti, distorsioni che graffiano fino a frantumare l’aria stessa. È un climax più oscuro del primo: lì il fiore pareva resistere, qui invece sembra soccombere, travolto dal cataclisma. Eppure nell’ultimo minuto riemerge, a disegnare una melodia sospesa tra tremoli di chitarra e note di piano ormai oltre il tempo, che si dissolvono nel vento sfumato dei ricordi. Resta soltanto una chitarra, avvolta da rumori di fondo in lontananza; forse è il mondo che non smette di esistere, o forse è solo il suono del nostro respiro stanco. E dunque dopo questa discesa nel caos, che non stonerebbe accanto a certe pagine di Dostoevskij, l’album si spegne senza veri trionfi; la sensazione è quella di aver attraversato l’oscurità di una notte grandiosa, forse la più importante di sempre, ed essere sopravvissuti.
A Single Flower non è un ascolto semplice, nemmeno per chi ama il post-rock: ha bisogno di tempo e dedizione, ma soprattutto del coraggio di restare nel cuore della tempesta. La scelta produttiva di contenere i volumi e dare respiro alla dinamica riduce la chiarezza nei passaggi più densi, ma mette comunque in luce il dialogo serrato delle tre chitarre, sempre eccellente, e la creatività dei pattern di batteria, tra i punti più alti del lavoro. In certi frangenti, come nella lunga “Blood Will Have Blood”, il disco rischia di perdersi in sé stesso: forse una divisione in due parti avrebbe dato più respiro alla scaletta. Ma tutto sommato è proprio in quell’eccesso che l’album trova la sua forza, se ci si abbandona al flusso con il giusto spirito. E dopo settanta minuti così intensi, quella che in fondo resta in mente è un’immagine tanto semplice quanto potente: il piccolo fiore rosso che resiste tra le macerie. Qui risiede il vero paradosso di A Single Flower, un’opera che scava nel cuore delle rovine e vi scopre la resilienza di ciò che resta in vita proprio grazie alla sua fragilità più autentica.
(Bird’s Robe Records, dunk!records, Translation Loss Records, New Noise, 2025)
1. If They Had Hearts
2. A Dance with Death
3. Everything Here Is Black and Blinding
4. Bloom (Murmurations at First Light)
5. The Gloaming
6. Blood Will Have Blood