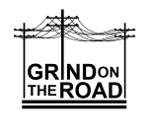BOOKWORM è la rubrica dedicata alle letture, questo numero è curato da Valerio Spisani
Vuoi proporci il tuo libro o ti interessa collaborare con noi? scrivi a redazione@grindob.cluster100.hosting.ovh.net

Di Simone Cicali, scrittore fiorentino classe ’71 che si autodefinisce “nerd da quando ancora questa parola era un’offesa”, è facile che non abbiate mai sentito parlare. Del resto, il panorama di quelli che si autopubblicano le cose è sterminato ed è pieno di fuffa, quindi avete tutte le ragioni per chiedermi chi diavolo sia ‘sto Cicali, uno che assieme a Lorenzo Leoni ha messo su il Sodalizio Wordsmith, e cioè una – e cito anche qua, scusate la pigrizia – “forgia letteraria, dalla quale usciranno le affilate armi dell’ingegno umano per combattere le ombre dell’ignoranza e riportare la Bellezza”. Molta roba che esce dal Sodalizio Wordsmith la potete trovare online, e c’è anche un patreon a cui potete iscrivervi, ma a vedere andateci dopo perchè prima vorrei parlarvi un attimo dei libri che il Cicali sta pubblicando in questi anni, anzi per l’occasione vi parlerò solo di uno di questi libri, quel Probabilmente che nel 2023 ha vinto il premio Ulthar nell’ambito dell’evento Libri da Yuggoth e che guarda caso ho letto da poco. Io vi devo confessare che il mio giudizio nei riguardi di questi racconti ‘ai confini della realtà’ è un po’ di parte, perché raramente in quanto lettore mi sono sentito così “spirito affine” con chi scrive. Al di là delle questioni anagrafiche (io e il Cicali siamo quasi coetanei) è proprio il background culturale che traspare – ma più che trasparire forse sarebbe meglio dire sgorgare a fiotti – dalle storie di Probabilmente che sento proprio vicino al mio, cioè mi vai a citare persino i volumetti de Star Trek: La pista delle stelle di James Blish, ma di cosa stiamo parlando, insomma! Quindi ecco, già si arriva in alto coi punti. Poi c’è la fantasia, sfrenata, le idee e gli spunti che danno vita ai racconti da cui traspare anche il meticoloso lavoro di documentazione che l’autore compie: tutto è estremamente lucido, preciso, e nonostante le bizzarrie qui presenti l’impressione è quella che in un qualche modo (o in un qualche mondo) quello che succede potrebbe verificarsi, o meglio, è probabile – per l’appunto – che si verifichi. Ora, detta così sembra quasi una cosa noiosa come il manuale di un’aspirapolvere ma vi assicuro che tutto scorre liscio e naturale come quando beviamo un kombucha, un po’ frizzantino e rinfrescante, profumato ma mai troppo dolce. Rispetto a Inaspettatamente (che è un’altra raccolta di racconti, sempre pregevolissima, uscita prima di questa) qua si vola ancora più in alto tra citazioni kinghiane (Il cane nero mi ha fatto venire in mente il fotocane), lovecraftiane (siamo tutti uguali) e tante altre suggestioni che magari ho visto solo io ma provando a immaginare quello che frulla nella testa del Cicali penso di non essere troppo lontano dalla verità. Oppure no, chissà, lasciatemi comunque fare i miei viaggi. Cercatelo.
 Parlando sempre di autori italiani, e anche di roba un po’ più robusta e decisamente vicina all’horror, non posso non parlarvi dell’ultima fatica di Luigi Musolino, ovvero il romanzo breve (o racconto lungo) Della donna aracnide, uscito per Zona42. Ora non so quanti di voi abbiano già avuto modo di leggere qualcosa di Musolino: se questa è la prima volta allora benvenuti nell’incubo, sennò sapete già quello che vi aspetta. Io considero Un buio diverso, uscito nel 2022 per Edizioni Hypnos, una delle più belle raccolte di racconti horror di sempre, non solo italiane e non solo contemporanee, e persino non solo horror, ecco, giusto per dirvi quanto sono fan dello scrittore piemontese. Le storie di Musolino vanno ad infilarsi nei più oscuri e misteriosi anfratti dell’anima, sono cupe, disperate, i suoi personaggi sono in balia dell’orrore, della depressione, del grigiore di un’esistenza che non riserva grandi speranze. Personaggi che chiunque di noi potrebbe aver conosciuto: il vicino di casa, quel tizio che al bar sta sempre da solo, l’impiegata delle poste o un proprio familiare. Tutta l’opera di Musolino è in realtà un unico, grande e terrificante, affresco: anche qui ritorna infatti, come in tutti i suoi altri lavori, il tema dei Necromilieus, luoghi misteriosi in cui il confine tra la nostra realtà e il male è più fragile, e insomma come potete immaginare questo male scalpita e vuole uscire e spargere la sua malignità nel nostro mondo. A me non piace mai raccontare trame o sinossi, vi basti sapere che qua si tocca anche il mondo del circo e dopo aver letto Della donna aracnide comincerete a guardare con occhi diversi quei tendoni che il circo Togni monta sempre alle periferie delle città. Buon viaggio.
Parlando sempre di autori italiani, e anche di roba un po’ più robusta e decisamente vicina all’horror, non posso non parlarvi dell’ultima fatica di Luigi Musolino, ovvero il romanzo breve (o racconto lungo) Della donna aracnide, uscito per Zona42. Ora non so quanti di voi abbiano già avuto modo di leggere qualcosa di Musolino: se questa è la prima volta allora benvenuti nell’incubo, sennò sapete già quello che vi aspetta. Io considero Un buio diverso, uscito nel 2022 per Edizioni Hypnos, una delle più belle raccolte di racconti horror di sempre, non solo italiane e non solo contemporanee, e persino non solo horror, ecco, giusto per dirvi quanto sono fan dello scrittore piemontese. Le storie di Musolino vanno ad infilarsi nei più oscuri e misteriosi anfratti dell’anima, sono cupe, disperate, i suoi personaggi sono in balia dell’orrore, della depressione, del grigiore di un’esistenza che non riserva grandi speranze. Personaggi che chiunque di noi potrebbe aver conosciuto: il vicino di casa, quel tizio che al bar sta sempre da solo, l’impiegata delle poste o un proprio familiare. Tutta l’opera di Musolino è in realtà un unico, grande e terrificante, affresco: anche qui ritorna infatti, come in tutti i suoi altri lavori, il tema dei Necromilieus, luoghi misteriosi in cui il confine tra la nostra realtà e il male è più fragile, e insomma come potete immaginare questo male scalpita e vuole uscire e spargere la sua malignità nel nostro mondo. A me non piace mai raccontare trame o sinossi, vi basti sapere che qua si tocca anche il mondo del circo e dopo aver letto Della donna aracnide comincerete a guardare con occhi diversi quei tendoni che il circo Togni monta sempre alle periferie delle città. Buon viaggio.
 Luigi Musolino è anche il curatore della neonata – ha poco più di un anno – collana Caronte, pubblicata sempre da Zona42 e che nel momento in cui scrivo consta di tre titoli, tutti di livello eccellente: la prima uscita è Il pescatore di John Langan, in cui viene utilizzato l’espediente delle scatole cinesi che di certo nuovo non è ma che in questo caso funziona alla perfezione. Avete presente no, quando leggete questo tipo di romanzi in realtà c’è una cornice che fa giusto da contorno alla storia principale, poi magari i due piani narrativi si intersecano pure ma spesso questa è la parte meno interessante. Qui no. Nella storia principale, dagli squisiti sentori kinghiani, Abe e il suo collega Dan, pescatori più per disperazione che per vera passione, durante le ricerche di luoghi in cui andare a pescare si imbattono in una leggenda del folklore locale che ruota attorno al Dutchman’s Creek e alla comunità che viveva nei paraggi. E qui parte una roba lovecraftiana che andrà a contenere un’altra storia, e tutto si interseca e si annoda senza mai un momento di stanca, riuscendo a mantenere vivo l’interesse fino in fondo. Cupo, struggente e dannatamente appassionante.
Luigi Musolino è anche il curatore della neonata – ha poco più di un anno – collana Caronte, pubblicata sempre da Zona42 e che nel momento in cui scrivo consta di tre titoli, tutti di livello eccellente: la prima uscita è Il pescatore di John Langan, in cui viene utilizzato l’espediente delle scatole cinesi che di certo nuovo non è ma che in questo caso funziona alla perfezione. Avete presente no, quando leggete questo tipo di romanzi in realtà c’è una cornice che fa giusto da contorno alla storia principale, poi magari i due piani narrativi si intersecano pure ma spesso questa è la parte meno interessante. Qui no. Nella storia principale, dagli squisiti sentori kinghiani, Abe e il suo collega Dan, pescatori più per disperazione che per vera passione, durante le ricerche di luoghi in cui andare a pescare si imbattono in una leggenda del folklore locale che ruota attorno al Dutchman’s Creek e alla comunità che viveva nei paraggi. E qui parte una roba lovecraftiana che andrà a contenere un’altra storia, e tutto si interseca e si annoda senza mai un momento di stanca, riuscendo a mantenere vivo l’interesse fino in fondo. Cupo, struggente e dannatamente appassionante.
 Nel secondo titolo uscito per Caronte, Siamo qui per farci del male, Paula D.Ashe ci va giù pesante fin dal titolo. Del resto cosa cerchiamo se non la sofferenza, l’oscurità, il male di vivere, la disperazione e la depressione, la perdita di ogni speranza voi ch’intrate, la violenza e il maligno quando leggiamo narrativa horror? Siamo qui per farci del male, per l’appunto (e Clive Barker sorride). Alcuni dei racconti più brevi – che magari presi da soli potrebbero sembrare un po’ inconsistenti – fungono da parti di raccordo tra quelli più corposi e succulenti e la qualità della raccolta, specie nella seconda parte, è di assoluto livello. Horror estremo? Può essere, ma non quello che vi potreste aspettare da un Edward Lee o da un Kristopher Triana, piuttosto qui si tratta di un estremo più “ligottiano”, se mi permettete il termine, più legato al male di vivere e alla bleakness che a schifezze & efferatezze. Legami familiari che diventano fonte di sofferenza, incesti queer, mutilazioni, riti innominabili e reinterpretazioni di celebri vicende di assassini seriali: piatto ricco mi ci ficco, e se volete qualcosa di forte che non sia un doppio shot di Nonino allora ficcatevici anche voi.
Nel secondo titolo uscito per Caronte, Siamo qui per farci del male, Paula D.Ashe ci va giù pesante fin dal titolo. Del resto cosa cerchiamo se non la sofferenza, l’oscurità, il male di vivere, la disperazione e la depressione, la perdita di ogni speranza voi ch’intrate, la violenza e il maligno quando leggiamo narrativa horror? Siamo qui per farci del male, per l’appunto (e Clive Barker sorride). Alcuni dei racconti più brevi – che magari presi da soli potrebbero sembrare un po’ inconsistenti – fungono da parti di raccordo tra quelli più corposi e succulenti e la qualità della raccolta, specie nella seconda parte, è di assoluto livello. Horror estremo? Può essere, ma non quello che vi potreste aspettare da un Edward Lee o da un Kristopher Triana, piuttosto qui si tratta di un estremo più “ligottiano”, se mi permettete il termine, più legato al male di vivere e alla bleakness che a schifezze & efferatezze. Legami familiari che diventano fonte di sofferenza, incesti queer, mutilazioni, riti innominabili e reinterpretazioni di celebri vicende di assassini seriali: piatto ricco mi ci ficco, e se volete qualcosa di forte che non sia un doppio shot di Nonino allora ficcatevici anche voi.
 La mia personalissima medaglia allegroni 2024 va invece a Qui, altrove, breve romanzo dello scrittore canadese Matthieu Simard, terza uscita per la collana Caronte, collana che promette e mantiene anche alla luce della lettura di Qui, altrove, un titolo che magari se vi aspettate un horror vero e proprio potreste rimanere delus* ma che riesce ugualmente a mettere i brividi, un po’ come le migliori storie di fantasmi sanno fare anche se qui non si tratta di storie di fantasmi. O forse sì, ma non voglio dirvi altro. Questo romanzo è andato a toccarmi delle corde che non ho mai molta voglia che vengano toccate, le corde della depressione, della tristezza e della disperazione, del trovarsi davanti a un qualcosa di insormontabile e perdere ogni speranza di farcela: insomma tutte cose forti che fanno venire un po’ di magone. Voi direte: ma chi te l’ha fatto fare? Eh, alla fine a me piace anche crogiolarmi in queste cose, se poi tutto è contornato da un’atmosfera – quella sì, che volendo ha più a che fare con l’horror – di minaccia intinta nel weirdness, con personaggi al limite del bizzarro e questa misteriosa antenna su cui meno si dice, meglio è, allora non ho nessun problema a gettarmi in questi pozzi oscuri. E magari ci sguazzo pure. Qui, altrove non è un romanzo per tutt*, secondo me per fare effetto deve proprio colpire quella parte di cuore che sanguina di più, e che se magari la tenete nascosta proprio perchè è la più vulnerabile allora rischiate che il colpo non vada a segno. Con me, ha fatto centro pieno.
La mia personalissima medaglia allegroni 2024 va invece a Qui, altrove, breve romanzo dello scrittore canadese Matthieu Simard, terza uscita per la collana Caronte, collana che promette e mantiene anche alla luce della lettura di Qui, altrove, un titolo che magari se vi aspettate un horror vero e proprio potreste rimanere delus* ma che riesce ugualmente a mettere i brividi, un po’ come le migliori storie di fantasmi sanno fare anche se qui non si tratta di storie di fantasmi. O forse sì, ma non voglio dirvi altro. Questo romanzo è andato a toccarmi delle corde che non ho mai molta voglia che vengano toccate, le corde della depressione, della tristezza e della disperazione, del trovarsi davanti a un qualcosa di insormontabile e perdere ogni speranza di farcela: insomma tutte cose forti che fanno venire un po’ di magone. Voi direte: ma chi te l’ha fatto fare? Eh, alla fine a me piace anche crogiolarmi in queste cose, se poi tutto è contornato da un’atmosfera – quella sì, che volendo ha più a che fare con l’horror – di minaccia intinta nel weirdness, con personaggi al limite del bizzarro e questa misteriosa antenna su cui meno si dice, meglio è, allora non ho nessun problema a gettarmi in questi pozzi oscuri. E magari ci sguazzo pure. Qui, altrove non è un romanzo per tutt*, secondo me per fare effetto deve proprio colpire quella parte di cuore che sanguina di più, e che se magari la tenete nascosta proprio perchè è la più vulnerabile allora rischiate che il colpo non vada a segno. Con me, ha fatto centro pieno.


Nel giro della new wave di autrici sudamericane che bazzicano col fantastico/horror/perturbante come Samanta Schweblin, Mónica Ojeda o Mariana Enriquez, Ampuero è quella che – per ora, non ho ancora letto nulla di Giovanna Rivero – colpisce più forte allo stomaco: i dodici racconti di Sacrifici umani, prima raccolta pubblicata da GranVia, sono autentiche mazzate in grado di lasciare a bocca aperta per la sensazione di orrore e disgusto che riescono a suscitare nel lettore. L’orrore di Ampuero è sicuramente quello squisitamente di genere – e io invito senza indugio gli appassionati di horror a farsi avanti e lasciarsi semplicemente spaventare da questi racconti, fatti di sudiciume e degrado – ma è soprattutto quello delle persone che vivono ai margini della società, delle donne schiacciate dalla violenza del patriarcato, delle discriminazioni e del marcio che si annida all’interno dei nuclei familiari in un paese dove l’istituzione della famiglia è considerata intoccabile («La famiglia è ancora intoccabile e le cose intoccabili sono pericolose perché possono diventare fascismo», ha dichiarato l’autrice in un’intervista). Insomma, l’orrore di Ampuero ci tocca molto da vicino, e per questo fa ancora più ribrezzo. Racconti preferiti Sanguisughe, Invasioni e Pietà. Amen. Se poi non vi bastasse, GranVia ha da poco pubblicato anche la prima raccolta di racconti di Ampuero, Le bestie, sempre eccellente e, crediateci o no, ancora più crudo nei contenuti. Prendeteteli tutti e due e avete risolto il problema.
 Ecco, adesso mi piacerebbe consigliarvi qualcosa che non c’entra nulla coi racconti ma con l’horror c’entra eccome: The soul of Wes Craven di Joseph Maddrey, pubblicato da Harker Press, minuscola casa editrice statunitense specializzata in saggi sull’horror americano. Come potete immaginare, il libro è una ricca biografia sull’autore di Nightmare e Scream, ricca nel senso che sono 450 pagine dense di notizie che partono dall’infanzia fino ad arrivare alla morte. Ora, nonostante sia stato una figura importantissima del cinema di genere contemporaneo io non ho mai considerato Craven uno dei miei registi horror preferiti, a parte Nightmare – che è forse il suo unico film che ritengo essere un capolavoro – altri suoi lavori sono buoni, alcuni buonissimi film, ma c’è anche tanta tanta fuffa (chi si ricorda di Dovevi essere morta??). La cosa più interessante, leggendo questa biografia, è capire come un pischello nato a Cleveland in una famiglia di fede battista abbia sia arrivato a girare quello che ha girato, anche se per tutta la sua carriera ha sempre sentito stretto il suo incasellamento nel genere horror (del resto se come primo film mi giri L’ultima casa a sinistra cosa ti aspetti? E infatti.) e ha sempre cercato di liberarsi da questo fardello ma – anche per questioni alimentari – gira e rigira è sempre rimasto a muoversi entro certi confini, a parte qualche rara eccezione (La musica del cuore). Inoltre, leggendo The soul of Wes Craven, risalta chiaramente come alcuni suoi film poco riusciti siano stati anche vittime di vicende produttive travagliate, e Craven era spesso il primo ad accorgersi che in questi film qualcosa non andasse per il verso giusto. Godurioso.
Ecco, adesso mi piacerebbe consigliarvi qualcosa che non c’entra nulla coi racconti ma con l’horror c’entra eccome: The soul of Wes Craven di Joseph Maddrey, pubblicato da Harker Press, minuscola casa editrice statunitense specializzata in saggi sull’horror americano. Come potete immaginare, il libro è una ricca biografia sull’autore di Nightmare e Scream, ricca nel senso che sono 450 pagine dense di notizie che partono dall’infanzia fino ad arrivare alla morte. Ora, nonostante sia stato una figura importantissima del cinema di genere contemporaneo io non ho mai considerato Craven uno dei miei registi horror preferiti, a parte Nightmare – che è forse il suo unico film che ritengo essere un capolavoro – altri suoi lavori sono buoni, alcuni buonissimi film, ma c’è anche tanta tanta fuffa (chi si ricorda di Dovevi essere morta??). La cosa più interessante, leggendo questa biografia, è capire come un pischello nato a Cleveland in una famiglia di fede battista abbia sia arrivato a girare quello che ha girato, anche se per tutta la sua carriera ha sempre sentito stretto il suo incasellamento nel genere horror (del resto se come primo film mi giri L’ultima casa a sinistra cosa ti aspetti? E infatti.) e ha sempre cercato di liberarsi da questo fardello ma – anche per questioni alimentari – gira e rigira è sempre rimasto a muoversi entro certi confini, a parte qualche rara eccezione (La musica del cuore). Inoltre, leggendo The soul of Wes Craven, risalta chiaramente come alcuni suoi film poco riusciti siano stati anche vittime di vicende produttive travagliate, e Craven era spesso il primo ad accorgersi che in questi film qualcosa non andasse per il verso giusto. Godurioso.