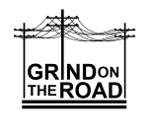Un’occasione per festeggiare, ma anche la presa d’atto dell’inesorabile scorrere del tempo… lo scoccare di un anniversario è sempre un’arma a doppio taglio, a maggior ragione quando la cifra oggetto della celebrazione assume i ragguardevoli contorni del mezzo secolo e se nel frattempo l’avvento di un nuovo millennio sembra invitare a considerare preistoria tutto ciò che abbia osato manifestarsi prima del grande giro di lancette iniziato nel Duemila.
In questo 2020, complice il cinquantennale del debutto degli universalmente riconosciuti progenitori Black Sabbath, tocca al doom affrontare la prova-ricorrenza, cercando di non perdere le coordinate di una giusta e opportuna devozione filiale che tenga lontano da un lato divinizzazioni fuori tempo massimo e dall’altro tentazioni di archiviare l’esperienza dei fab four di Birmingham sotto la voce «reperti archeologici». L’approccio più corretto è, come sempre, quello di considerare la musica come una forma di linguaggio, soggetta dunque alle inevitabili modifiche figlie dello scorrere del tempo e dei mutamenti sociali e culturali delle società in cui si aggira quotidianamente. In quest’ottica, allora, ha poco senso domandarsi quanto resti di autenticamente sabbathiano nei lavori delle band oggi ricondotte alla galassia doom, così come è altrettanto controproducente rinchiudersi nelle torri d’avorio del «Naah, ormai nessuno inventa niente, c’era già tutto nell’album x della band y», dietro cui si nascondono approcci da pensionati in perenne scuotimento di cranio ai margini dei cantieri, nella fattispecie pentagrammatici. La verità è che, soprattutto dopo l’incontro con la poetica death e gothic e le relative contaminazioni, il doom del Terzo Millennio è in larghissima parte oggettivamente diverso da quello delle origini ed effettivamente un ipotetico viaggiatore del tempo che tornasse a solcare le onde radio, finanche su un canale specializzato, faticherebbe a ritrovare nella stragrande maggioranza delle produzioni contemporanee le sonorità di una “N.I.B.” o di una “The Wizard”. Con simili premesse, paradossalmente, sono proprio le band che hanno scelto di riproporre gli stilemi delle origini a rischiare di più, esponendo il fianco a facili accuse di venerazioni anacronisticamente coltivate, senza la necessaria apertura alare e puntando solo sull’effetto vintage. D’altro canto, riuscire a sopravvivere in un habitat a così alto e feroce tasso di selezione naturale è già una grande prova di forza e non stupisce che tra i superstiti la qualità tenda ad essere di tutto rispetto. Ed è senz’altro questo il caso dei tricolori Suum, comparsi sui radar due anni fa con il già convincente Buried into the Grave e pronti ora a spiccare un volo ancora più ardito con questo Cryptomass. Figlio (a pari titoli genitoriali) sia della prima ondata doom di stretta osservanza sabbathiana (con Saint Vitus e Pentagram sugli scudi, sul versante ascendenze) che della mareggiata novantiana successiva alla scossa Candlemass e Solitude Aeturnus, il quartetto capitolino si ripresenta sulla scena sfoderando un carico di personalità significativamente incrementato rispetto al debutto, tale da garantire una resa ancora migliore nella gestione del rapporto con gli augusti modelli. Gli ingredienti della cucina Suum sono quelli tradizionalmente attesi su queste frequenze, a partire dalla pesantezza soffocante delle strutture dei brani e da una mai celata propensione alla magniloquenza epicheggiante, ma va detto che i Nostri non si attardano mai in un banale lavoro di carotaggio dell’arsenale settantiano con l’intento di riprodurne i classici canoni hard rock, psych o occult rallentando semplicemente i ritmi o incupendo le sonorità. Ciò che sembra scaturire con disarmante naturalezza è soprattutto una sensazione di mirabile equilibrio tra le componenti del platter, con la sezione ritmica Grave/Kemper addetta a innalzare e scolpire monoliti, le sei corde di Painkiller che valorizzano la funzione-cardine del riff (sempre speso in termini di essenzialità sfruttandone le potenzialità da “fulmen in clausula” che piomba su un tappeto cadenzato) e la voce di Mark Wolf capace di spaziare su tutto lo spettro teatrale del cantato, sia che si tratti di declamare quasi in modalità voce fuori campo, sia al momento di iniettare nelle atmosfere vapori malinconicamente illanguiditi. Chi abbia una pur vaga dimestichezza con l’italica nicchia doom, peraltro, saprà già che dietro lo pseudonimo in questione si nasconde quel Marco Veraldi che abbiamo imparato ad apprezzare alla guida della fuoriserie che risponde al nome di Bretus e non avrà problemi ad accostarsi al suo clean, più che legittimamente accostabile ai fasti di un Johan Längquist ai tempi dell’imperituro monumento Epicus Doomicus Metallicus. Quando poi, come nella magnifica titletrack che apre le danze, Veraldi si permette di avvicinare la decadente voluttuosità che ha reso immortale Aaron Stainthorpe e il resto della band si perde con pari costrutto nelle atmosfere My Dying Bride, la sensazione di essere al cospetto di un grande album è praticamente immediata e non subirà smentite per il resto del viaggio. Oltretutto, ai Suum non manca la capacità di sorprendere: il finale sludge-oriented della successiva “The Silence of Agony” o il retrogusto spiccatamente avantgarde di “Creatures from the Vault” dimostrano su quante frecce possa contare l’arco di questi ragazzi. Anche se è innegabile che i brividi migliori arrivino quando si entra nella macchina del tempo, come nella saintvitusiana “Funeral Circle”, chiusa da un delizioso ricamo di Painkiller in versione slowhand, o tra le spire solennemente cerimoniali della notturna “Burial at Night”. Dopo il leggero calo da registrare con la troppo scolasticamente compassata “The Failure of Creation”, si riparte per il gran finale con i vapori velenosi esalati dalla luciferina “Claws of Evil” e, ancora meglio, con “Reaper Looks in Your Eyes”, dove Mark Wolf nicotinizza il cantato e occupa il centro della scena in modalità Scott Wino Weinrich prima che tutto sfumi in un’aura carica di mistero e riverberi occult.
Tra echi di un’epoca temporalmente distante, ma ancora in grado di allungare ombre feconde su un presente che deve molto a quella stagione di eroici pionieri, e devozioni equilibrate che non diventano mai freddo citazionismo o comoda scorciatoia per intercettare consensi, Cryptomass è un album che innesta alla perfezione radici antiche in un terreno che ha ancora molto da offrire, agli amanti del doom di antico e nobile lignaggio. La partenza dei Suum è stata folgorante, ma sul futuro pesa l’incognita della dipartita di Marco Veraldi, annunciata proprio in prossimità del rilascio del nuovo album. Al suo successore, Filippo Fossà “Misantrophil”, i migliori auguri per raccogliere un’eredità scomoda ma al tempo stesso più che stimolante, potendo anche contare su compagni di viaggio di assoluto valore.
(2020, Seeing Red Records)
1. Cryptomass
2. The Silence of Agony
3. Creatures from the Vault
4. Funeral Circle
5. Burial at Night
6. The Failure of Creation
7. Mass in the Catacomb
8. Claws of Evil
9. Reaper Looks in Your Eyes