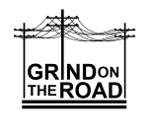VIDEO NASTY è un termine coniato in Inghilterra negli anni 80 dal comitato censura per indicare i film da VHS che avevano un contenuto violento o comunque mal visto.
Questa rubrica parla di cinema ed è a cura di Carmelo Garraffo ed Emiliano Zambon.
Se vuoi proporci un film da recensire o collaborare con noi, scrivi a redazione@grindontheroad.com
 BRING HER BACK di Danny Philippou, Michael Philippou (2025)
BRING HER BACK di Danny Philippou, Michael Philippou (2025) PUSH di Justin Powell, David Charbonier (2024)
PUSH di Justin Powell, David Charbonier (2024)
Può un film partire bene e finire malissimo? Si, ne abbiamo visti tanti, ma PUSH rientra in una categoria tutta sua. Ora vi spiego.
I primi trailer del film non spiegavano tantissimo e mostravano per lo più una donna sola aggirarsi da sola all’interno di una casa molto grande e molto buia, coi suoi rumori e suoi soni a dirci che probabilmente tanto sola poi non è. In più le scritte a schermo non ci giravano tanto intorno, cose come “il miglior home invasion dell’ultima decade” e altre frasi altisonanti che volevano sottolineare che questo film di cui non hai probabilmente mai sentito parlare è il realtà una perla incredibile. I due registi hanno già girato degli horror che rientrano tranquillamente nella categoria “ok per una serata senza impegno” e la sensazione, visto il marketing, è che forse sono pronti a fare il salto, ad aggiungere in spessore quel tanto che basta per diventare un piccolo fenomeno o, perlomeno, un film che ricorderemo con affetto. Inizi a vedere il film e, onestamente, ci credi. C’è questa giovane agente immobiliare, vedova e incinta, sola in questa grossa casa che sta cercando di vendere e, come ci fa intuire trailer e marketing, qualcuno a un certo punto cerca di entrare. Ci credi perché sembra ben girato e in qualche modo crea la giusta atmosfera. Certo, stiamo parlando di meccanismi molto classici che riguardano il buio, i rumori, il vento, le ombre ma tutto sembra girato con criterio e funziona, con la speranza che il film usi bene i classici meccanismi del genere per creare un buon film. La sensazione è quella che si voglia guardare al passato per andare verso il futuro, sopratutto perché la nostra protagonista si aggira per questi corridoi e queste infinite stanze con in mano un candelabro e la sensazione è davvero quella di un vecchio gotico nel castello sostituito con qualcosa di più moderno e, come ho detto, i tempi funzionano e il film ti fa rimanere in tensione. Ill problema però si pone quando, dopo questa prima parte, ti rendi conto che il film non ha davvero nessuna intenzione di mettersi a fare qualcosa abbia un minimo di originalità. Pensato a un film ben girato ma con una storia di fondo talmente banale che se vi dessi un paio di elementi riuscireste senza troppi problemi a raccontarvela in testa da sola senza aver bisogno di vedere il film realmente. Se vi dicessi che bussano alla porta e la protagonista va ad aprire? Se vi dicessi che a un certo punto arriva una persona che potrebbe dare una mano? quello che potrebbe succedere sono sicuro che lo sapete già. In conclusione continuo a pensare che sua un peccato dato che la regia si difende bene ma è un film che avete già visto.
Non faccio fatica a credere che sarà distribuito, prima o poi, anche in Italia
recensione Carmelo Garraffo
 BRICK di Philip Koch (2025)
BRICK di Philip Koch (2025)
È uscito su Netflix questo mese un film tedesco che stavo aspettando da parecchio tempo. Il motivo non è per via delle chiacchiere, delle voci o di chissà che cast alle spalle (l’unica faccia nota l’avete già vista nella serie DARK) ma, semplicemente, perché la sua locandina stazionava nella sezione “attendere col fiato sospeso” da almeno un paio di anni e la curiosità era molta nonostante non avessi la più pallida idea della trama e del genere. Poi, a sorpresa, pochi mesi fa compare una data e una trama striminzita. Una coppia in crisi non riesce a uscire dalla propria abitazione perché viene improvvisamente isolata da dei muri. Il primo pensiero va a tutto quel filone di film tipo “the cube” in cui i protagonisti dovranno ingegnarsi, indizio dopo indizio, tentativo dopo tentativo, per riuscire a venirne fuori e magari scoprire cosa sta succedendo. Per fortuna siamo proprio da quelle parti perché, almeno per il sottoscritto, è un sottogenere che mi diverte sempre. Ve lo dico subito, non stiamo parlando del film dell’anno o di una piccola perla che tutti dovrebbero conoscere ma nel suo essere molto semplice risulta carino da guardare, e poi ha senso scrivere in queste pagine anche di qualcosa che potete andarvi a vedere subito. Gli ingredienti sono quelli che il genere impone: dei personaggi, un enigma, un avanzamento, l’incontro con altri personaggi seguiti da tensioni fra loro fino alla risoluzione finale. È un male? In questo caso non credo che lo sia perché il solo scopo che il film si pone è quello di intrattenere generando mistero e curiosità e ci riesce fino a un finale leggermente diverso rispetto alle mie aspettative. Se siete amanti di questo sottogenere di film e vi trovate in quelle classiche serate stallo dove continuate a fare avanti a indietro dai cataloghi delle vostre piattaforme senza sapere cosa guardare, alla ricerca di quel qualcosa che vi faccia passare la serata senza l’impegno che un film più stratificato richiederebbe, allora questo film potrebbe fare per voi.
recensione di Carmelo Garraffo

La Città Proibita di Gabriele Mainetti (2025)
Il cinema di genere italiano lo ha sempre fatto. Prendere i generi che non sono originari del nostro cinema, mescolarli con altri ingredienti e sfoggiare uno stile peculiare che in qualche modo funziona. Lo ha fatto con gli Spaghetti Western, con il Giallo e il supereroistico, quindi perché non provare la stessa formula con i film di Kung Fu? Spaghetti o noodles, è solo questione di gusti, dopotutto. Gabriele Mainetti, che dopo Lo Chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out di flirt con i sottogeneri ormai ne sa qualcosa, ritorna con la sua personale visione di un heroic bloodshed per le strade di Roma, una resa dei conti tra gangster locali e triadi. In mezzo, una ragazza cinese pronta a farsi strada a pizze, calci e ossa rotta per ritrovare la sorella scomparsa insieme all’amante, il proprietario di una trattoria romana frequentata dal boss locale, uno scandalo che potrebbe rompere una fragile tregua tra questi e le triadi. Quando i due amanti vengono ritrovati la guerra tra gang sembra imminente e la vendetta, per la ragazza, l’unica via rimasta. La Città Proibita funziona molto bene nel primo atto in cui Mainetti e i suoi stabiliscono bene la posta in gioco nel conflitto per ogni personaggio, puntellando di street cred le ottime sequenze di combattimento dallo stile non prettamente asiatico, quindi con meno accento su coreografie meticolosamente montate su campi ampi, ma più moderno e vicino alle produzioni americane ed europee fatte di shaky cam e montaggi rapidissimi. Funziona tutto molto bene, anche grazie alla stilosa fotografia e alla creativa interazione con gli elaborati set che evidenziano la differenza culturale tra i due mondi, ma anche per l’atletismo e le acrobazie della brava Liu Yaxi, atleta marziale che si è fatta le ossa come stunt nel remake live-action di Mulan. Le cose tuttavia cominciano a scricchiolare nella sezione centrale a causa del cambio di configurazione del genere, un cambio di marcia dall’azione a un’epica gangster speziata con del melodramma e del romanticismo che guarda chiaramente alla poetica di John Woo pur continuando a marciare alle sue condizioni, ma l’arresto nel ritmo e la differenza tra generi che rifiutano di amalgamarsi in modo elegante è troppa da colmare. Mainetti alla fine recupera con le battaglie finali, ma il sapore amaro del blocco centrale rimane. Alla fine però non guasta troppo il divertimento e La Città Proibita rimane un film interessante, polposo e stiloso. È una creatura rara che in quanto tale merita interesse, affetto e applausi più di quanto meriti le critiche. Una specie di nuovo e fresco mix, lo spaghetti bloodshed, per cui tifare fortissimo anche se il risultato non è così profondo ed epico come nelle intenzioni del suo regista.
recensione di Emiliano Zambon  The Surfer di Lorcan Finnegan (2024)
The Surfer di Lorcan Finnegan (2024)
The Surfer segue un uomo che torna in Australia dopo una vita negli Stati Uniti, sperando di riacquistare la sua casa d’infanzia su una spiaggia isolata. Quello che si presenta come un nostalgico ritorno però si trasforma rapidamente in un incubo quando viene umiliato di fronte al figlio adolescente da un gruppo di surfisti territoriali che rivendicano la proprietà sulla spiaggia dove un tempo giocava da bambino. Rifiutandosi di arretrare, scatenerà una battaglia psicologica per il territorio che lo spingerà al limite della sanità mentale. Se amate i character study intensi, di quelli che ti entrano sottopelle, con un debito di gratitudine agli anni ‘70 e alle droghe psichedeliche, The Surfer è il trip che fa per voi. Un film che esplora il tema dell’identità, della mascolinità tossica, dell’appartenenza a un branco e cosa succede quando il proprio senso di sé viene completamente stravolto. Una sorta di Point Break mescolato a Wake In Fright ma dal sapore distintamente aussie, tanto familiare quanto profondamente alienante. È anche un film perfettamente a misura del particolare approccio di Nicolas Cage. La sua totale dedizione al ruolo, la capacità di puntare al confine tra vulnerabilità, imprevedibilità e follia lo rende perfetto per un personaggio la cui presa sulla realtà si fa sempre più tenue, incanalato in un incubo delirante che il regista Lorcan Finnegan ha scelto di girare in un’unica location, generando un’atmosfera altamente claustrofobica e surreale perfettamente funzionale al gioco della tensione psicologica, forte di un pregevole ensemble di attori australiani che non si limita a fornire un semplice contorno al protagonista: lo sfidano, portano una tensione autentica senza mai perdere il vantaggio psicologico del film. The Surfer è il tipo di opera dal tono e dall’atmosfera unici che ti ricorda perché il cinema può essere un’esperienza così potente. È bizzarro, affascinante e al 100% Nicolas Cage. Che siate fan di lunga data del suo lavoro o che cerchiate semplicemente uno strano thriller psicologico in questi mesi torridi, The Surfer è un brivido estivo che non vorrete perdervi.
recensione di Emiliano Zambon

Spermageddon di Tommy Wirkola, Ramus A. Sivertsen (2024)
L’improbabile partnership tra il regista norvegese di commedie horror Tommy Wirkola e il suo connazionale Rasmus A. Sivertsen, animatore e regista di film per famiglie, combina l’irriverente talento del primo con il tocco innocente di Sivertsen, per un film che sfida ogni categorizzazione; una sorta di viaggio dell’eroe tra Inside Out e un episodio di Rick and Morty all’interno del corpo umano catturato dal punto di vista di una coppia di spermatozoi mentre cercano di fecondare l’ovulo affrontando un micro mondo testicolare irto di pericoli, ma anche di un paio di adolescenti nel mondo esterno alle prime esperienze che cercano di prevenirlo. L’avventura interna non sarà sempre biologicamente accuratissima ma è ricca d’azione, simpatici giochi di parole (l’ho detto che i due gameti si chiamano Semen e Cummilla?), gag, twist e strizzate d’occhio a tanti classici del Cinema, ma anche di accattivanti numeri musicali che vanno da cori di spermatozoi a ginecologi che sostengono la pianificazione familiare. Mentre fuori, l’incontro tra i due innamorati umani si giustappone alle vicende degli spermatozoi come una commedia sessuale per adolescenti debitamente cringe con il focus sui rapporti consensuali e il sesso sicuro. Perché nonostante l’umorismo sfacciato (ma gestito con un tocco leggero, da film per famiglie) e l’approccio spensierato, il film riesce anche a trasmettere messaggi importanti sulla salute e le relazioni sessuali in un modo accessibile e divertente grazie alla riuscita miscela di commedia e contenuti pedagogici, sfidando i tabù sociali con un tocco leggero e un cuore inaspettatamente grande.
recensione di Emiliano Zambon