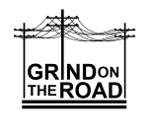PANOPTICON è la gabbia in cui abbiamo volontariamente scelto di isolarci. Uno spazio che dedichiamo alla musica che più ci piace, e di cui preferiamo parlare senza alcuna fretta. Da, diamo uno sguardo a tutto ciò che abbiamo trascurato nei mesi scorsi e facciamo una cernita delle primizie musicali più particolari, assorbendo e godendo di ogni loro cellula.
Tutte le recensioni sono di Antonio Sechi, ad eccezione di As the Moon Rests che è a cura di Federico Botti e Smashing Pumkins a cura di Stefano Naim.
![]()
 LONG DISTANCE CALLING > ERASER
LONG DISTANCE CALLING > ERASER
Curioso come una musica come quella contenuta in questo Eraser non si avvalga di una voce, perché ne accrescerebbe notevolmente l’impatto sonoro, ma ce la teniamo così. Ci accontentiamo, perché comunque sono le soluzioni melodiche apportate dalle chitarre a cantare. Si tratta di qualcosa che attinge da una natura progressive, che grazie al cielo non va a pescare direttamente da quello spirito settantiano che alla lunga inizia ad essere troppo citazionistico, nostalgico quasi che spesso non porta nessuna innovazione al genere e per carità, magari non c’è nessuna intenzione per quanto riguarda il voler rinnovare queste sonorità, ma a un certo punto le cose si fanno fin troppo stantie. I Long Distance Calling invece ci danno modo di ascoltare qualcosa che potrebbe risultare metal sotto il punto di vista della produzione, ma che è essenzialmente rock. Le strutture sono squisitamente elaborate e anche la scrittura dei singoli strumenti presenta una lunga ponderazione; ogni nota e ogni fraseggio cerca di apparire complesso, stratificato. Ma non serve una conoscenza pregressa della musica complicata per definizione perché qui è la melodia a fare da padrona. Senza mai dimenticare che è musica dura quella che si sta ascoltando, un brano come “500 Years” pone tutte le premesse di questo complesso conglomerato di nature diverse fra loro. È un disco consigliatissimo per chi ha voglia di qualcosa di interessante e che offre una vasta quantità di sensazioni.
 A.A WILLIAMS > AS THE MOON RESTS
A.A WILLIAMS > AS THE MOON RESTS
Una poesia oscura lunga undici tracce, una narrazione potente, emotiva, sensuale ma allo stesso tempo dilaniante nei suoi toni dimessi e fortemente malinconici… As the Moon Rests di A. A. Williams è questo e altro, è puro sentimento. Coadiuvata da una sezione di archi e da un mestiere che, nonostante i due soli album alle spalle, le permette di valicare generi e barriere, la Nostra si lancia in un buio compendio della psiche umana. Attraverso il rock alternativo, quello cantautorale, il dark folk e accenni di metal, ricordando ora Chelsea Wolfe, ora Emma Ruth Rundle, ora Darkher, e contemporaneamente staccandosi da tutte per originalità e stile, la cantautrice ci regala un disco tardo autunnale, perfetto per crogiolarsi nella malinconia più profonda che ci avvolge come una calda coperta.
 VIAGRA BOYS > CAVE WORLD
VIAGRA BOYS > CAVE WORLD
I Viagra Boys, questi giovani pazzi abbiamo imparato a conoscerli nel tempo. Con Cave World non sono andati distanti dal loro seminato ma se mi è permesso devo dire che questo disco suona ancora più citazionistico dei precedenti e, non mi riferisco solo al pezzo “Troglodyte” che è in pratica una variazione di “The Girl U Want” nella versione dei Devo, ma anche a tutto il resto che cita continuamente i The Jam e Sham 69 senza mai dimenticare il synth punk dei già menzionati Devo, Futurisk e Primitive Calculators. Ma questo lo sappiamo già. In sostanza Cave World è un lavoro frenetico e molto divertente e trasporta con sonorità liquide in un mondo colorato e pieno di pixel. Dettaglio che rende il tutto interessante è una sorta di ruvidezza aggressiva che non lascia dubbi su quanto sia punk lo spirito che brucia in questa musica. Da scoprire.
 SMASHING PUMPKINS > ATUM ACT I
SMASHING PUMPKINS > ATUM ACT I
L’ennesima trovata di Billy Corgan. L’inconfondibile (e incontenibile) voce, frontman e deus ex-machina delle “zucche” di Chicago partorisce stavolta un’opera (rock): 3 atti (il primo ora, gli altri nel 2023) per 33 tracce complessive che comporrebbero – a suo dire – il seguito di Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) e Machina/The Machine of God (2000). Compagni di viaggio in quest’ultimo, strabordante progetto 2 membri originari della band (James Iha alla chitarra, Jimmy Chamberlin alla batteria) e Jeff Schroeder, fidato ‘Pumpkin’ della nuova era. Con queste – “pompose”, come il nostro eroe – premesse ci accingiamo all’ascolto. Che, sin da subito, ci indirizza sulle coordinate del suo predecessore (Cyr, 2020). L’attuale amore di Billy Corgan sono i synth: che stavolta – più del capitolo precedente – flirtano con le chitarre, ma rimangono l’ossatura centrale dei pezzi, a rispecchiare una proposta sonora che assume, a volte platealmente, contorni dance-rock di stampo anni ’80. Se questo è (piaccia o meno) l’impianto di base, è la qualità complessiva, purtroppo, a mostrarsi debole: alcune tracce appaiono francamente scadenti (“Where Rain Must Fall”, “Hooray”, “The Gold Mask”) molte vivacchiano senza sussulti (“Butterfly Suite”, “Embracer”, “Hooligan”). Le migliori soluzioni, in effetti, si intravedono laddove gli onnipresenti tappeti di synth si intrecciano con più vigore alle chitarre, giustificando – almeno in parte – la presenza di James Iha e offrendo trame meno piatte e ripetitive: non disprezzabili, in tal senso, la strumentale title-track (intro del disco) gli scossoni di “The Good in Goodbye”; il pop di “With Ado I Do”; “Beyond The Vale” (un “aggiornamento” sferragliante della precedente “Cyr”). Nel complesso, però, ad ora troppo poco. Non resta che attendere (con fiducia?) i prossimi atti.
 NOFX > DOUBLE ALBUM
NOFX > DOUBLE ALBUM
Il canto del cigno, questo è Double Album e va detto, ci vuole un affetto molto grande nei confronti di questi titani del punk per considerare buono questo disco. La band ha annunciato lo scioglimento che avverrà nel corso del 2023. Un saggia decisione dal momento che cercare ancora di essere/fare punk alla mezza età non può che far apparire falsi o ridicoli, ma noi non siamo qui giudicare le scelte di una band che ha saputo fare del proprio sound una carriera. Double Album è un disco che apre una serie (stando alle loro dichiarazioni) di dischi che usciranno di seguito. Si tratta sostanzialmente dell’ombra di quello che è stata la band in passato; ovviamente fare confronti è sempre ingiusto, ma Double Album a un primo ascolto risulta abbastanza forzoso, pare trascinarsi un po’ per dovere e un po’ per inerzia, ma dopo ascolti ripetuti appare subito chiaro che qui stiamo ascoltando una band stanca, fiacca, senza più una vera idea. Riff che richiamano vecchi miti, un drumming molto alleggerito e privato di una qualsivoglia fantasia, per non parlare di Fat Mike, che è ovvio, non ce la fa più. Tutto questo è molto triste e io stesso avrei voluto non essere cattivo nei confronti di una band che ha appassionato tanti, me compreso, ma le cose stanno così, ma almeno abbiamo il conforto che si ritirino dignitosamente, anche se hanno avuto tutto il tempo di esprimere la totale mancanza di nuove idee.
 CANDLEMASS > SWEET EVIL SUN
CANDLEMASS > SWEET EVIL SUN
Esattamente come si parlava poco sopra sui NOFX anche qui bisogna applicare il discorso sulla longevità di una band, una band che ormai esiste da decadi, una band che diede alle stampe uno fra i più fondamentali dischi per un genere come il doom metal, ma questi non sono più quelli di Epicus Doomicus Metallicus, sono una band che ha ceduto all’età e Sweet Evil Sun lo dimostra a più riprese. Non fraintendiamoci, lo spirito compositivo è sempre lo stesso e per questo ne siamo grati, ma anche qui le idee sono andate scarseggiando, cercando di fare leva più su un fattore produttivo che musicale. Questo nuovo disco infatti non sembra voler effettivamente dare qualcosa di cui gioire ai fan della band o più generalmente del genere tutto. Nell’arco di nove brani più una conclusione sono rari i momenti in cui i maestri del doom riescono ad acchiappare davvero l’ascoltatore, magari giusto sul finire del brano “Angel Battle”, momento del disco in cui abbiamo modo di assaporare quel retrogusto caro a chi è cresciuto con sonorità epicamente pesanti, ma si tratta solo di un’impressione perché la profondità del contenuto qui è davvero poca.
 ††† (CROSSES) > PERMANENT.RADIANT
††† (CROSSES) > PERMANENT.RADIANT
Ormai da Chino Moreno dobbiamo aspettarci di tutto, non si può più parlare di una vera e propria identità dell’artista, di personalità sì, senza dubbio perché il leader dei Deftones tutto è fuorché prevedibile e questo di per sé rappresenta una concreta personalità. Ormai fa quello che gli pare e con Shaun Lopez questo è possibile. Permanent.Radiant si presenta come un disco che nasce da una natura prettamente metal e rock, lo si può sentire benissimo in “Vivien”, però la confezione è prettamente elettronica, finanche pop di tanto in tanto. Ora, per un ascoltatore di metal, che magari ha anche apprezzato i primi lavori dei Deftones questa roba qui potrebbe risultare uno scherzo, un dispetto, ma la realtà è che si tratta di uno di quei side project del tenore dei Puscifer, ASHES dIVIDE, The Black Queen, ecc… tutte cose che possono fornire un secondo o terzo o anche quarto alle volte, sguardo sulla visione di alcuni artisti che magari hanno posto le basi di un appassionato. Invero in questo EP non ci sono nuove idee che possono trasformare un’uscita di musica elettronica qualunque in qualcosa per cui vai a pensare “ok, aspetta che qui c’è qualcosa dietro”; di sicuro si tratta di un lavoro fatto da gente completamente cosciente di come si fa la musica quando la si vuol fare di qualità e spessore ma non è un discorso da potersi applicare all’ascolto totale, perché ci sono casi in cui i Crosses si lanciano in quello che risulta essere quasi un pezzo reggaeton (“Day One”), dettaglio che potrebbe compromettere molto la poca fiducia che uno scettico si è imposto di avere. Nel complesso, senza tirarla troppo per le lunghe, si tratta di un lavoro che sotto certi aspetti non fornisce grandi sensazioni, sembra più che altro puntare a farsi riprodurre a una festa serale in spiaggia e mi rendo conto che trattandosi di Chino Moreno e tutte le conseguenze che ne derivano (come uno zoccolo duro di fan sfegatati) questa può sembrare una disanima impopolare, finanche offensiva. Ma non si può lasciare che le fette di salame tagliato grosso restino belle aderenti alle orecchie e che schiaccino lo spirito critico. Per concludere, disco preparato da mani più che sapienti, ma non così propense a fare qualcosa di spessore.
 MAMMOTH WEED WIZARD BASTARD > THE HARVEST
MAMMOTH WEED WIZARD BASTARD > THE HARVEST
Se The Harvest dovesse essere definito con una parola sola sarebbe senza dubbio: obnubilante. Le maniere pesanti di uno stoner allucinato si sposano con delle melodie vocali ipnotiche, che assieme a dei synth fantascientifici, che pare stia per atterrare un’astronave aliena, fanno del contenuto di questo disco una valida colonna sonora per momenti di profonda riflessione personale. Si nota fin da subito una presenza fissa che è quella di Vangelis, è infatti impossibile non notare in un brano come “Interstellar Wrecking” le sonorità sentite nella colonna sonora di Blade Runner. La pazienza fa parte di The Harvest, ci sono pezzi abbastanza longevi e tal volta si fa sentire questa lunghezza per merito di una non troppo elaborata progressione compositiva, ma si tratta di una caratteristica fondamentale per donare quell’aura di ipnotismo al disco, che è sotto molti aspetti praticamente perfetto nel suo piccolo. Consigliatissimo, da non perdere per un amante dello stoner e di sonorità stregonesche